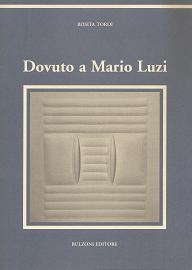Dal volume di Rosita Tordi Castria Dovuto a Mario Luzi, Roma, Bulzoni, 2007, pagg. 27-42:
Poesia, pittura e … un po’ di strada
Nel libro/conversazione Leggere e scrivere del 1993 Luzi confessa esplicitamente l’ apertura di un dialogo privilegiato con i pittori già negli anni del suo apprendistato poetico: “La tensione a captare il vivente o gli affetti o le suggestioni del vivente con il segno, con il colore, è una tentazione quasi irresistibile; la pittura sembra una via forse meno essenziale però più breve e più drastica della parola, del linguaggio della parola. Quindi l’attenzione al lavoro dei pittori per me è sempre stata molto viva, anche quando, finita la stagione che Rilke chiamò del visibile, che io posso tradurre un po’ più grettamente la stagione delle corrispondenze, riconoscibili con il dominio del senso e dell’esperienza, quindi del figurativo, la pittura si è avventurata in moltissime direzioni senza alcun ancoraggio subalterno. La tavolozza di un pittore o comunque il regime preferenziale dei suoi colori mi suggestiona sempre e mi attizza, mi acutizza la disparità fra senso e parola. Il lavoro del pittore mi spinge ad appuntire sempre più il linguaggio, a renderlo sempre più preciso, più ricettivo di luci, di suoni, di tonalità, di circostanze, di frangenti, che rimangono presi dentro il linguaggio come dentro un cristallo. Poi ci sono pittori che hanno un mondo, che agiscono all’interno di questo, come può essere Morandi, come può essere Rosai, per dire i due grandi della mia stagione formativa. C’erano anche altri pittori molto interessanti, ma nuclei di ordine morale ed espressivo insieme, come sono Morandi e Rosai, mi sembrano unici, a parte quello del tutto immaginario e bellissimo di De Chirico”(1).
All’inventore della Metafisica Luzi deve essersi avvicinato casualmente e per suo conto già nei primi anni Trenta e tuttavia anche in questa direzione importante deve essere stata la mediazione di Giorgio Morandi, il pittore bolognese incontrato a Firenze intorno al 1937/’38. Un incontro diventato subito un’amicizia che si è intensificata nel biennio 1938-’40 trascorso a Parma. Nel corso di un’intervista per “Il Resto del Carlino” del 6 ottobre 1994, Luzi si diffonde sulle incursioni domenicali a Bologna, nella casa-studio di Morandi: “Era emozionante – confessa all’intervistatore Carlo Donati – entrare in quella casa di Via Fondazza, così spartana. Ma era anche un po’ imbarazzante dover attraversare la camera delle sue sorelle per andare nel suo studio. Morandi mi portava in giro per la città a vedere e rivedere chiese e monumenti. Se ho capito qualcosa di Bologna lo devo a lui e a quelle lunghe passeggiate. (…). Diciamo che vedevo Morandi attraverso Rosai e Morandi era uno dei pochi artisti, se non l’unico, che Rosai metteva su un piedistallo. Ma la stima era corrisposta. Vivevano in mondi lontani eppure erano molto legati. Morandi veniva abbastanza spesso a Firenze e Rosai aspettava con una certa ansia le sue visite, credo che lo temesse anche un po’” .
E alla domanda sulle ragioni della seduzione esercitata su di lui dalla pittura di Morandi : “L’assolutezza dello stile, del segno, del colore, quegli elementi essenziali che da soli esprimevano il senso totale della vita. Prendiamo quegli oggetti quasi neutri. La penetrazione visiva e la trasfigurazione stilistica non sublimano soltanto l’oggetto in sé, ma lo innalzano a segno di conoscenza totale”.
E’ di fatto quella di Morandi una lezione di architettura compositiva, di purezza formale, di nitidezza di stile, che si propone a Luzi come una operazione atipica di innovazione nel rispetto della tradizione lungo una linea che ha un referente decisivo nella grande pittura metafisica di Giorgio de Chirico e di Carlo Carrà.
Nella Lettera a Massimo Carrà, figlio dell’artista, datata Firenze, maggio 1971, Luzi non esita a confessare: “Può sembrare strano, ma non mi si era mai presentata prima l’occasione di scrivere su Carrà se non per inciso, scrivendo di altro. Me ne rammarico. Rimpiango di non aver avuto il destro di farlo quando era il tempo per me più propizio, cioè quando s’inaugurava il rapporto o, dopo, via via che si sviluppava e chiariva. Oggi, temo, è un po’ tardi per ritrovare quel minimo di lucidità e d’invenzione che deve esserci e in effetti è in qualsiasi rapporto: o, se vuoi una frase forse un po’ meno barbara, nella scoperta e nella conquista progressiva di un’alterità situata di fronte a te sia pure con autorità e valore di esempio.
Il rapporto non è dunque più operante? Beh direi che il rapporto non è più un vero rapporto. Alla lunga è accaduto a me come a tanti altri della mia generazione che il teorema fondamentale e il linguaggio, insomma la ragione pittorica di Carrà, sono divenuti qualcosa di implicito, una specie di substrato, assai più che culturale della mia educazione.
A questo punto scrivere di Carrà è un po’ come scrivere dell’alfabeto che usi appunto scrivendo, e soprattutto scrivendo di queste cose: il che non esclude l’emozione perché anche le lettere si trasformano, magari soltanto e più che mai per quel che sono. Ma vuoi mettere quando le stai imparando? Come ogni grande artista anche Carrà non si finisce tanto presto d’impararlo, d’accordo. Anche lui ha i suoi segreti lenti ad affiorare. Ma più di ogni altro contemporaneo ti comunica il fervore del primo apprendimento”(2).
E superata la soglia della captatio benevolentiae la lettera si risolve in una riflessione penetrante, punteggiata da sciabolate di luce sulla vicenda di un rapporto intellettuale estremamente fecondo per il poeta il quale si chiede: “Da che viene a Carrà questo potere maieutico che oltrepassa la pur grande bellezza e la pur non rarissima insicurezza delle sue immagini?”.
Rispondere a questa domanda vuol dire per Luzi, che ha appena pubblicato Su fondamenti invisibili, la raccolta che segna uno degli esiti più alti della sua vicenda poetica, ancora una occasione per uno sguardo retrospettivo, a chiarezza di sé. In primo luogo richiama la riflessione di Carrà sulla pittura delle origini: “L’artista si è spiegato bene con la sua sommaria e tanto più efficace attività teoretica a cominciare dalla Parlata su Giotto che è del 1916. Il lavoro di messa a punto dei critici gli è andato da presso. Si può dire che tutto sia stato ben formulato per ciò che riguarda il ripristino (non certo la restaurazione) dei valori elementari della tradizione più sostanziale, il potente effetto di riordino sugli episodi dispersivi e dissipatorii dell’arte proto-novecentesca, e insomma quello che Longhi chiama il riavvio della pittura italiana.
Tutto è stato anche detto, e detto bene, sul piglio morale di tale impegno, sull’onestà e sulla severità che ne discendono, come caratteri attuali e intrinseci, alla visione di Carrà. E’ ormai letteratura corrente, ma non per questo degradata. Tout se tient, è vero, nel nudo universo disciplinare in cui l’artista si fortificò, senza peraltro trincerarsi” .
E subito dopo, nei modi un po’ dimessi di una conversazione amicale, un affondo critico di singolare efficacia: “Eppure rimane inesplicato quell’ingenuo pregio di fondazione che assume la pittura di Carrà negli anni matematici che vanno dal 1914 alla fine degli anni venti e attraversano impunemente, anzi vittoriosamente la prova degli ismi.
Nella prospettiva aperta dai cinque decenni che sono seguiti è proprio questo dato, non scomponibile in fattori di nessun genere, primario, che mi commuove di più riconoscere: (…) quell’ingenuità, quell’anima romantica affiorata al momento del più radicale proposito”.
In questa direzione documento di particolare rilievo un foglio autografo inedito, rinvenuto nelle cartelle in cui ci è stato consegnato il manoscritto di Al fuoco della controversia, assai probabilmente il frammento di un più lungo testo senz’altro utilizzato successivamente nella Lettera a Massimo Carrà: “ (…). Ma quella di cui parlo è invece una ingenuità creativa, una condizione integra che non fa a pugni per nulla con l’agguerrita ideologia formale e neppure con l’ideologia politica che le soggiace. Bene o male, più bene che male, sappiamo insomma tutto dell’animus di Carrà; ed ecco, o mi sbaglio, egli ci viene incontro con la parte meno ricostruibile di se stesso, quell’ingenuità, quell’anima romanica affiorata al momento del più radicale proposito,
Nella giostra delle poetiche così è molto avveduto oltre che istintivamente sicuro anche prima di aver bloccato il problema risolutivo della questione dei famosi valori plastici. Le immagini futuriste e quelle metafisiche si distinguono nel concerto anche per quella sobrietà e quella solidità che poi da semplice intuizione diventeranno fondamento strutturale del suo linguaggio. Ma a distinguerle mi pare ancora più decisiva quella casta aderenza all’oggetto che neppure la loro estrazione fantastica e teorica basta a convertire in ‘idea’. Né la Galleria di Milano né il Cavaliere occidentale o L’amante dell’ingegnere ci appaiono infatti riflessi del senso o feticci dell’intelletto. Sono privi di magia e di sortilegio. Il fatto è che la fede nella loro sostanza di cose è piena e non solo di forme. Carrà non è un pittore in cui il filtro intellettivo, meno ancora intellettualistico, possa avere gran gioco: la sua casta natura apprensiva nei riguardi delle cose, dei (…)”.
Nel retro del foglio sono disordinatamente annotati versi relativi alla raccolta poetica del 1978, e tuttavia lo scritto citato è senz’altro molto anteriore e comunque precede la Lettera a Massimo Carrà del 1971 nella quale alcuni passaggi sono puntuali citazioni da quel foglio autografo: “Nella giostra delle poetiche Carrà è molto avveduto, oltreché istintivamente sicuro, anche prima di aver bloccato il problema risolutivo sulla questione dei famosi valori plastici.
Le immagini futuriste e quelle metafisiche si distinguono nel concerto anche per quella sobrietà e quella solidità che poi da semplici inflessioni diventeranno fondamenti strutturali del suo linguaggio. Ma a distinguerle mi pare ancora più decisiva quella casta aderenza all’oggetto che neppure la sua estrazione fantastica e teorica basta a convertire in “idea”. (…) E’ come una rivelazione primaria del peso, del volume, della forma dei corpi quale si può avere in uno stato di piena e integra credulità e di non sofisticato amore, di carità naturale”.
E quindi portando alla più palpabile evidenza il gioco di specchi confessa tra le righe il tentativo da lui esperito nella poesia degli esordi di prendere al pittore il ’suo’ bene: “Quanto a me, penso che gli effetti dell’astrazione metafisica non siano da meno di quelli posteriori dell’astrazione fisica nell’esaltare quel dono, quel privilegio che Carrà aveva dalla sua. Non sono da meno, ma forse di più difficile evidenza rispetto al paesaggio visibile della fase centrale. Allora le pietre di paragone sono più scoperte e più chiare. I monti: dei coni puliti e massicci, eppure non ideografici; realtà non semplificata ma semplice com’è quando la prima attenzione la percepisce ed è ancora tutta credibile. Il mare: una massa d’acqua compatta, cioè la scoperta del suo primo attributo. La barca: un legno concavo che rompe la superficie”.
E’ questo candore figurale che presiede all’operazione culturale dell’incontro con la pittura di Carrà. Si direbbe infatti che la stessa scelta del titolo della prima raccolta, La barca, in sostituzione di Fisica perfetta, proposto in un primo momento, discenda dalla seduzione esercitata su di lui dalla pittura di Carrà in cui la barca è un elemento iconico ossessivamente ricorrente.
Nondimeno l’ascendente di Giorgio de Chirico è nel percorso poetico del primo Luzi più ‘antico’ e incisivo che non quello di Carrà. Recita un penetrantissimo profilo, Imponente e taciturno anche al Caffè Greco, che il poeta consegna al “Corriere della sera” del 22 giugno 2004: “Non riesco a stabilire una data agli inizi del mio fervore dechirichiano. Certo è che quando già nel pieno della sua fortuna espose a Firenze, mi pare a Palazzo Ferroni dove avvenivano le consacrazioni, io ancora liceale avevo già Giorgio de Chirico tra i miei santi. Come era entrato nel mio paradiso? Non può essere accaduto se non per via fotografica in virtù di qualche riproduzione vista e contemplata nelle vetrine delle gallerie o di pubbliche sale.
L’arte di de Chirico aveva lì, pensavo, il suo punto di forza: e lo pensavo tra me e me di fronte alle sue celebri tele metafisiche anche prima che la voce di Roberto Longhi, qualche anno più tardi, insinuasse nei miei orecchi argomenti di dissuasione come faceva contro le predilezioni dei letterati.
Ma su questo suo orrore antiletterario avevo a mia volta i miei motivi di rivalsa su certi suoi falli che avrebbe preferito che fossero dimenticati. Schermaglie spiritose con il grande critico consentite a me, battitore libero come si suol dire e non ai componenti della sua formidabile equipe di allievi.
Mi sono chiesto negli anni successivi e più insistentemente a cose mutate, in un clima diverso di tutte le manifestazioni vitali e specialmente delle arti, di che natura fosse quella malia. L’estetica certo c’entrava per qualcosa, ma l’estetica si rapportava a un mondo assai misterioso che ti veniva incontro paradossalmente in una stregonica fissità. Era la Grecia, i suoi miti famosi, i suoi mitici eroi. Avevano perduto la sacralità del culto vivo presente, così dislocati com’erano in uno spazio alieno, in una prospettiva improbabile, ma acquistavano un’autorità nuova di emblemi della sospensione della conoscenza – declino, tramonto, aurorale ulteriorità del sapere umano?
L’ambiguità pareva il fondamento di quella imagerie che la luce intensificava. Luce tagliente creatrice di miraggi e di fughe del pensiero. Una morfologia stralunata e potente nasceva proprio da quell’equivoco: guardare, pensare e vedere. Ed era una morfologia rigorosa.
Si era ancora oscuramente in un’imprecisa ma forte inquietudine, simile all’agitazione degli animali nell’imminenza del terremoto, quando io mi trovavo alle prese con la suddetta emozione dechirichiana.
Ripensandoci oggi a ritroso mi pare di avere, confortato dalla “ragion veduta”, più netta la causa probabile di quella suggestione.
Era nell’aria, era in gioco la sorte di quella civiltà che aveva avuto quei segni. La percezione di un trapasso epocale si appigliava a quell’indeciso significare dei corpi, dei simulacri, dei manichini, delle luminose cornici plateali, delle aperture invitanti del pittore di Volos.
(…).
Nonostante tutto le immagini di de Chirico non cessarono di incantarmi anche quando divennero dipinti in tela e cornice davanti ai miei occhi. Si, la superficie poteva apparire assai illustrativa, poco pittorica; ma era quella la loro forma e d’altronde la potenza allucinatoria dei miti evocati non poteva essere negata se non per partito preso, s’imponeva in sé. Il bello è che nel suo lungo decorso il tardo de Chirico sembrò andare incontro o meglio sfidare i suoi detrattori sfoderando tutte le risorse di una sapiente cucina pittorica, eccessiva fino al virtuosismo. Pictor optimus, infatti.
Ma, per tornare alle immagini di quelle tele, esse non rimasero per me soltanto una lingua splendidamente morta nel profondo della memoria, e neppure un sibillino annuncio poetico e formale, infraloquirono non poco con la mia immaginazione, credo, e influirono sul linguaggio di Avvento notturno che allora stavo componendo ed era il momento che esse venivano deglutite e assimilate alla stagione del surrealismo”.
Resta il fatto che ancora nell’ explicit di Un brindisi, la composizione apparsa per la prima volta nella rivista “Prospettive” del 1942 in cui si manifesta una vocazione poematica che denuncia l’allontanamento dal linguaggio di stretta osservanza simbolista di Avvento notturno, si è in presenza di immagini peculiari della iconografia dechirichiana:
Voi dal cavo delle orbite occhi immoti
nel cielo esterrefatto,
fissità delle maschere contorte
in una smorfia eterna: siete voi
il silenzio ostinato della terra,
voi di là dall’estate dei giardini
nel sole basso ordito dalle piante.
E sempre contro il cielo vi vedremo
esitanti a parlare della morte,
noi l’uno all’altro simili e indistinti
nell’attendere, numeri non volti (3).
La fissità delle maschere contorte enfatizza la situazione di sospensione, di attesa agghiacciante, percorsa da brividi di morte, emblematica della inaudita violenza che nei primi anni Quaranta fa irruzione nel vissuto quotidiano.
Recita l’autocommento di Luzi in una lettera all’amico Bilenchi del 22 gennaio 1942, a proposito di Un brindisi, il poemetto pubblicato in “Prospettive” nel fascicolo del 15 aprile-15 maggio 1941: “In essa i contenuti sono esposti nella stessa squallida vivacità in cui si presentarono e dopo l’accenno a un equilibrio tra l’uomo e il sensibile, rotto questo accordo, l’immaginazione si accende dietro a invenzioni desolate e nude, prive di umanesimo, direi, che vengono poi a significare la solitudine, l’inoggettività della nostra vita interiore. In ultimo c’è l’allusione a un mondo puramente formale e, ora mi pare, platonico. Vedi ora tu stesso come queste strane cose che sono venute a determinarsi in me, risultano nel testo”.
E a distanza di un anno, in una lettera a Spagnoletti: “Certamente è vero quello che tu hai per primo capito, che cioè dopo l’Avvento ho lavorato con maggiore tristezza e con più convulsa inquietudine, con meno calma, come se mi fossi precipitato con la fine dell’Avvento in una zona proibita. E ho dovuto resistere molto a quella tendenza a volatizzare, a scorporarsi in puro movimento, molto al di là delle parole, che era in effetti la logica conseguenza dell’aver toccato comunque la mia entelechia notturna e fenomenica. E se in quello che ho fatto dopo c’è qualcosa di buono è, di certo, la conversione all’umano, al naturale e all’elementare umano della mia antica febbre e follia: soltanto quella conversione può aver restituito un corpo pesante alla mia parola, la può aver trattenuta nel cerchio dei significati”(4).
Si vanno di fatto precisando, in quei primi anni Quaranta, le linee guida di quella che Stefano Agosti, nel saggio pubblicato nel fascicolo di maggio del 1991 di “Strumenti critici”, definisce “una carriera espressiva prodigiosamente virata in una crescita ininterrotta, tappa dopo tappa, e a dispetto di esiti già sommi“.
La riflessione di Agosti disegna una linea interpretativa tesa a “recuperare alla posizione di Luzi un’immane tradizione speculativa che ha i suoi punti nevralgici nei presocratici (soprattutto Eraclito e Parmenide) e in quella modernità che parte da e si riconosce in Nietzsche (…): ove la “verità” sta non tanto nell’univocità d’un significato ultimo e definitivo che il sapere dovrebbe raggiungere e far proprio, ma piuttosto nel processo interminabile d’uno “svelare” che non cessa di dire l’enigma che lo abita e lo costituisce”.
In questa direzione un segnale di qualche interesse in un articolo che Luzi non ancora ventenne consegna alla rivista “Il Ferruccio” del 5 agosto 1933 con il titolo Intellettualismo e poesia. Il suo giudizio sulla poesia italiana contemporanea è tranchant: “Non è proprio la poesia molto nutrita di pensiero che siede nelle preferenze dei poeti ed esteti ultimi” e perentoria la sua richiesta che un flusso di pensiero “venga come a solidificare la labile trama delle composizioni poetiche di questi ultimi anni”.
Soltanto due anni dopo pubblicherà con l’editore Guanda i versi della sua prima raccolta poetica che, fino nel titolo, La barca, configura quella idea della poesia come viaggio, ricerca di verità, forma di conoscenza (5), cifra di un percorso poetico che si snoda lungo il secolo, fino a lambire il nuovo millennio, facendo registrare esiti singolari negli anni Settanta quando il dialogo con la pittura trova interlocutori autorevoli nell’ambito di quegli artisti nei quali è riconoscibile l’ascendenza dello Spazialismo di Lucio Fontana.
Differenziandosi e dalla spazialità atmosferico-impressionista e da quella astratto-costruttivista, il pittore italo-argentino mira alla creazione di uno spazio artistico differenziato rispetto all’ambiente e al tempo stesso non riferibile ad alcuna realtà estrinseca o intrinseca.
Se pittori quali Burri e Fautrier, rappresentano lo spazio come un muro impenetrabile, espressione di una impossibilità conoscitiva, Fontana taglia quel muro creando un’interferenza tra lo spazio reale e quello virtuale.
E’ l’inizio di una nuova avventura: “Io buco, passa l’infinto di li, passa la luce, non c’è bisogno di dipingere….tutti hanno creduto che io volessi distruggere – dichiara Fontana - ma non è vero, io ho costruito, non distrutto, è li la cosa”. Esiste una realtà perfettamente vera, trascendente quella concreta, che la fisica contemporanea, la filosofia, l’astronomia, insomma le discipline di frontiera della conoscenza, vanno delineando: l’universo come continuo pluridimensionale dove le misure ordinarie di spazio, tempo e dimensione non hanno luogo.
Particolarmente importante l’ascendente di Lucio Fontana nella pittura di Enrico Castellani alla quale Luzi nel 1994 dedicherà il saggio introduttivo al volume Quindici superfici bianche di Enrico Castellani: “Mi è difficile riconnettere l’arte di Castellani a una precisa tradizione, sebbene, è chiaro, antecedenti di grande forza nel campo astratto, in quello concettuale e in altri adiacenti abbiano spianato la strada a questa mia stupefatta lettura. Sono, in questo secolo, da Mondrian a Fontana, i maestri di un serio anche se spesso illusorio ripensamento dell’uomo in rapporto al conoscibile e del conoscibile rispetto a quell’uomo avvertito. Ma alcuni hanno la grazia di modulare in armonia, in ritmi mentali incisivi e toccanti, quella investigazione. Proprio a quella virtù si deve lo straordinario effetto d’infinito che promana da quelle immagini. (…).
La tabula di Castellani può essere all’origine o all’epilogo della creazione. I primordi o la desertificazione postuma del pianeta della vita possono ugualmente riconoscersi nella simmetria di quel pettinato e tanto più allucinante diagramma. Poche volte come leggendo questo grafema a rilievo, ordinato e uniforme, si ha il sospetto non poco emozionale che il principio sia uguale alla fine”.
Il bianco è icona dell’invisibile, dell’inizio, del limite, designa lo spazio delle infinite potenzialità della creatività e quelle tele bianche di Castellani offrono a Luzi l’occasione per una riflessione in primo luogo a chiarezza di sé. Trasparente il gioco di specchi e palpabile il coinvolgimento emotivo: “La vita deve ancora venire o ha già esaurito la sua breve fase su quella superficie sempre uguale a se stessa? La storia umana inciderà qualche segno o è già trapassata senza lasciare traccia? La fertilità deve ancora apparire o si è già ritirata?
I corrugamenti vari, le inclinazioni della luce, il proiettarsi di quei punti in un verso ascendente o declinante dicono probabilmente le alternanze degli eventi su quel frammento del cosmo e sulla mente che, esposta alla loro nuda violenza, li registra e li finge. Nella sospensione di ogni giudizio l’attesa e il rimpianto possono assimilarsi. Ma ha senso distinguerli? L’ambiguità è essa stessa uno stato, e, in questo caso, uno stato non transitorio, tendenzialmente assoluto.
Castellani pone un interrogativo totale: e la risposta non urge dal momento che ci occupa e forse ci appaga la sua stessa pura contemplazione” .
E’ in questa disposizione che Luzi si accosta all’opera dell’amico scultore Venturino Venturi. Nel saggio Venturino Venturi. Un creatore di forme vive, per il fascicolo di maggio della rivista fiorentina “Quadrante” del 1963, schizza sveltamente un ritratto che lascia intravvedere le ragioni di quella che doveva diventare una lunga consuetudine: “Isolato e rapito nella sua passione plastica, Venturino medita, Venturino rimugina; come ogni solitario, contiene un rudimentale filosofo; interroga il mondo da capo come se nessuno lo avesse fatto prima di lui. Le risposte più che il pensiero gliele fornisce l’istinto e l’intuito, ma senza quel rovello che tiene desti lo spirito e la fantasia né l’istinto né l’intuito sarebbero così pronti ed accesi.
Così la sua prepotente esigenza creativa lo rimanda intuitivamente al principio della creazione; lo riconduce all’origine del mondo formato: la maternità e più oltre l’embrione, la cellula vivente, la radiazione dell’energia. Mirabilmente è questo universo allo stato di nascita perenne, non ancora formale, che si esprime in forme assolute, unitarie, solari nella plastica e nel segno di Venturino, quasi ne avesse carpito la misura e la regola e, quel che più conta, la grazia. Allo stesso tempo la plastica e il segno sono ricondotti all’origine della loro natura e della loro funzione”.
E a distanza di cinque anni, in piena bagarre sperimentalista, nel saggio Venturino Venturi degli anni ’60 per il fascicolo 96 di “Critica d’arte”, Luzi sottolinea come il discrimine tra figura e astrazione appaia in questo caso insensato “di fronte all’unica potenza e autorità della forma-creazione, così religiosamente sentita da risarcire, per puro effetto di profondità, la crisi, lo scetticismo e le lacerazioni di oggi. Come se Venturino toccando il prodigio del vivente nel punto dov’è inesauribile, leggesse nel nostro tempo più a fondo e con misure diverse da quelle episodiche. (…). Non sarà male aggiungere infatti che l’elementare di Venturino non reca traccia di quegli arcaismi deliberati della volontà novecentesca di ricominciamento; e neppure di quel processo reattivo di natura schizoide scatenato dalla società e dalla storia di questi decenni”.
E’ evidente che qui Luzi scrive in primo luogo a chiarezza di sé: l’opera dell’amico scultore non è più che un pretesto per lanciare il suo j’accuse nei confronti dello sperimentalismo della poesia italiana di quegli anni. Un atteggiamento sostanzialmente non diverso, anche se espresso in termini non altrettanto perentori perché assai mutato è ormai il quadro culturale rispetto agli anni Sessanta/Settanta, torna nel saggio L’arte e la vita: Venturino, per il fascicolo 20 del 1989 di “Critica d’arte”: “Ciò che meraviglia nell’arte di Venturino, anche a ripensarla in prospettiva, (…) è che quella immunità del pedaggio alla Koiné non la estranea per nulla dall’epoca e dal suo patema. E’ dunque così diverso, così poco riducibile all’ordine vigente, che è appunto quello della metodica disobbedienza all’ordine mentale precostituito e quello delle metodiche sperimentazioni? La risposta potrebbe essere, né più né meno, la seguente: Venturino è un artista fondamentale, e cioè chiama in causa, non per discuterlo ma per ritrovarlo integro ed esaltarlo, il fondamento dell’arte che pratica. Ripensamenti radicali sia della ragion d’essere sia della peculiarità dei linguaggi delle varie arti non sono stati rari nell’epoca moderna e anzi ne contrassegnano il corso fino da quando essa cominciò a volersi definire tale e tale denominarsi. Quelle riconsiderazioni, dal Simbolismo al Suprematismo, erano prima di tutto operazioni critiche, talora sostanziali, talora sofisticate e pretestuose. In Venturino si tratta invece di un ritrovamento di necessità, quasi di una reintegrazione nel primario che il linguaggio plastico avesse dimenticato. Il linguaggio plastico è per Venturino il linguaggio materno, generativo, e cioè cosmico”.
Il saggio del 1989 è anticipato da una riflessione, ancora una volta sintomatica di un atteggiamento critico che tende a ‘piegare’ l’opera in esame a testo di prova per fare in primo luogo chiarezza del proprio poein, pubblicata nel 1984 come prefazione al volume delle Edizioni Pananti di Firenze Con gli uomini e con gli angeli: Venturino Venturi sulle tracce di Dante.
Se si tiene conto che la rilettura di Dante per la mediazione di Eliot ha intensamente impegnato la riflessione critica di Luzi svolgendo un ruolo incisivo nella evoluzione del suo discorso poetico intorno agli anni Cinquanta, indagarne la presenza nella formazione dell’amico scultore è ancora un’occasione a chiarezza di sé: “Ai primi approcci l’arte di Venturino mi venne incontro dalla pienezza di un energico e già composto amalgama di espressività e di sapienza costruttiva. Era ancora molto giovane e mostrava opere eseguite in età ancora acerba. Stupivo di quella luce di classicità non cercata che sublimava immediatamente quella vocazione a plasmare e l’altra, simultanea, a esprimere, a interpretare. (…). Siamo intorno agli anni Cinquanta: sono di quel periodo alcuni tra i “memorabili”, più intensi raggiungimenti della scultura di Venturino: la specificità della plastica vi si dichiara in tutta la sua disciplina e spontanea potenza: la sua armonia con la verità dell’oggetto non si smaglia per nessuna impurità. Il rapporto tra espressività e struttura formale è così alto e perfetto che la profonda scienza o tradizione che lo ha reso possibile si meraviglia di essere così “presente” e viceversa il presente si meraviglia di riscoprirsi così antico”. Quindi un ricordo personale: “In quel periodo – siamo negli anni Cinquanta – si colloca il bel ritratto che mi fece studiosamente cercando l’equilibrio tra la penetrazione intellettiva e morale del suo elettivo modello e la struttura. (…). Ma proprio allora, simultaneamente, produceva alcuni straordinari esempi di discrezione, per così dire, incidentale, di persone distinte e quasi restituite alla vicenda della materia. (…). Erano forme aperte in cui ogni discriminazione tra circoscritto e non limitato, tra immagine e astrazione, veniva inopinatamente bruciata”. E riguardo al suo incontro con l’opera di Dante, in particolare con la terza Cantica: “Anch’egli ha condotto mirabilmente, tra chiari volumi, luminose assenze di volume, tracce, aggregazioni e rarefazioni di segni, la sua schermaglia contro il limite, contro l’insufficienza umana del mezzo che insegue per catturarlo il linguaggio della luce, della danza, della assoluta quiete contemplativa, sapendo che anch’esse non sono che “traduzioni”, “imbriferi prefazi”. Per questo il radioso abisso che Venturino ha rivelato e celato con quella sua abbagliante fenditura lineare è la più viva promessa per la nostra richiesta”, dove il personale coinvolgimento del poeta – critico è esibito senza esitazione.
Sulla stessa lunghezza d’onda il saggio del 1991 dedicato all’amico scultore in occasione di un volume che ordina e raccoglie un centinaio di disegni non figurativi eseguiti all’incirca negli anni Ottanta /Novanta, Venturino Venturi: moti e ricerche verso l’infinito, per le Edizioni Pananti di Firenze: “Astratto, Venturino?
Anche senza rispolverare i pensieri avuti in passato a proposito della sua ideazione formale e dunque senza speculare ancora una volta, teorizzando un poco sull’archetipo oculare che è il punto di partenza e di arrivo di quel processo ideativo e plastico, una scorsa a questo riepilogo ci avverte di quanto sia impropria quella distinzione.
Non c’è una fase che si possa dire concettualmente astratta, non esiste un procedimento astrattivo nel corso artistico di Venturino; e non si oppongono a nessun’altra più realistica o figurale stagione. (…). La gloria formativa della genesi è la musica più forte e continua che risuona in quello spazio, dove l’uomo sembra assente, sparito o non ancora nato”.
Torna alla mente l’explicit della lettura delle tabulae di Castellani: “Ma non si tratta, e questa è la vera chiave, di puro effetto bensì di una attitudine vera e profonda della mente di fronte al mistero della materia, dello spazio e del tempo e della loro percezione meravigliosa”.
All’amico scultore Luzi dedica la composizione Atelier di Venturino, una sorta di emblematico fermaglio che chiude Al fuoco della controversia, la raccolta poetica del 1978:
L’esserci, il primo
e più nudo dei misteri – gli chiedo
dichiarando il come,
gli chiedo il perché. Si sposta
verso il profilo
della sua incarnazione lui, scompare
sotto flutti d’oscurità.
Umilmente
se no,
all’altro capo dello stesso enigma
lui nel bulbo del sonno
si prepara, lui sente
già alta sulle dune
la stella puntata sulla sua natività. E stupisce,
stupisce di questo –
Pensieri
che ho avvertito, vibranti
nell’aria, svegli
tra la pietra intatta
e quella già formata. O atelier.
E’ il richiamo a una modalità di intendere l’esperienza del quotidiano in rapporto sempre con l’assoluto ma è al contempo l’atto di fede nell’arte come unica forma di conoscenza.
1) M.Luzi – M.Specchio, Luzi. Leggere e scrivere, Firenze, Nardi, 1993, pp.31-32.
2) M. Luzi, Carlo Carrà in Luzi critico d’arte a c. di N.Micieli, Firenze. Lo Gisma editore, 1997, pp. 46-49.
3) M. Luzi, Un brindisi in L’opera poetica, op. cit., p.100.
4) M. Luzi, L’opera poetica, op. cit., p. LXXXII.
5) M. Luzi, La barca, Modena, Guanda, 1935.