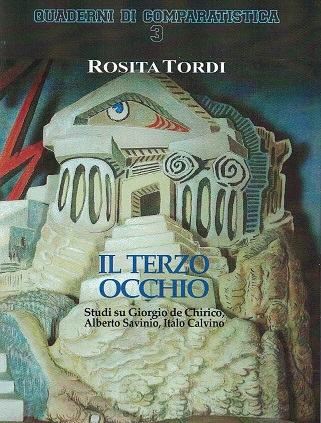Dal volume di Rosita Tordi Castria Il terzo occhio. Studi su Giorgio de Chirico, Alberto Savinio, Italo Calvino, Moncalieri (To), CIRVI, 2015, pagg. 63-84:
Calvino tra Parigi e Roma:1967-1985
Recita l’explicit di Cominciare e finire, uno degli ultimi scritti di Calvino, datato 22 febbraio 1985:
All’ineluttabile trionfo dell’entropia, Mallarmé risponde contrapponendole i suoi perfetti cristalli di parole, pur sapendo che la loro sostanza è la stessa cui tende l’universo: la negazione, l’assenza, il niente. Rien è la prima parola del primo verso del sonetto che apre le sue Poésies.
Con esso posso chiudere la mia rassegna degli inizi, ma non senza ricordare l’ultima prospettiva che Mallarmé propone: “que tout, au monde, existe pour aboutir à un livre” (che tutto, al mondo esiste per terminare / metter capo a / un libro).[1]
Una fede assoluta, quella professata dall’ultimo Calvino, nel potere conoscitivo della Letteratura, che di fatto sostanzia tutto il suo percorso creativo e di riflessione sull’arte.
Consistenti al contempo i debiti contratti con le arti visive e in particolare con quel coté della pittura del Novecento che in qualche misura gravita intorno a Giorgio de Chirico, alle cui Piazze d’Italia Calvino dedica nel 1983 un penetrante racconto/saggio.[2]
In Visibilità, la penultima delle Lezioni americane, confessa:
Quando ho cominciato a scrivere storie fantastiche non mi ponevo ancora problemi teorici; l’unica cosa di cui ero certo era che all’origine d’ogni mio racconto c’era un’immagine visuale (…) carica di significato anche se non saprei formulare questo significato in termini discorsivi o concettuali.[3]
Subito dopo una dichiarazione perentoria:
Comunque, le soluzioni visive continuano ad essere determinanti, e talora arrivano inaspettatamente a decidere situazioni che né le congetture del pensiero né le risorse del linguaggio riuscirebbero a risolvere.[4]
Emblematica la scelta di far riprodurre in copertina del volume Le città invisibili, nella prima edizione Einaudi del 1972, il dipinto di René Magritte, Il castello dei Pirenei, conservato nel Museo israelitico di Gerusalemme: un castello sulla sommità di una roccia sospesa a mezz’aria, fluttuante, al di sopra di una vasta distesa marina punteggiata da scogli.[5]
Il dipinto è del 1959 e appartiene a quel ciclo di composizioni, iniziato da Magritte nei primi anni Cinquanta, in cui tema centrale è un processo di pietrificazione che esercita i suoi effetti globalmente: non è in gioco il destino di un singolo essere vivente o di un semplice oggetto ma è il mondo intero a diventare di pietra.
È il caso di La parole donné del 1950, La voix active e Souvenir de voyage, entrambi del 1951, La chambre d’écoute del 1952, Le monde invisible del 1954, Les origines du language del 1955, La bataille de l’Argonne del 1958, Le clef de verre del 1959, Le sens des réalités del 1963, composizioni pittoriche che devono aver inciso in profondità nell’immaginario di Calvino.
Si direbbe che, seppure per l’immagine di copertina delle Città invisibili abbia privilegiato Le château des Pyrénées, a fermare in particolare la sua attenzione, al di là della suggestione del titolo, sia stato il dipinto del 1954, Le monde invisible, dove la stessa esasperata associazione di elementi incongrui palesa l’ascendente di Giorgio de Chirico: un grande masso ‘approda’ sul parquet di un appartamento davanti a una finestra che si affaccia su una vasta distesa marina sovrastata da un cielo tempestoso.
Viene alla mente un passaggio del capitolo V°, nucleo germinativo di Le città invisibili:
Dall’alta balaustra della reggia il Gran Kan (…) contempla un impero ricoperto di città che pesano sulla terra e sugli uomini, stipato di ricchezze e d’ingorghi, stracarico d’ornamenti e d’incombenze, complicato di meccanismi e di gerarchie, gonfio, teso, greve.[6]
Si configura un mondo di impenetrabile opacità e pesantezza in cui si dispiega l’assioma del pensiero negativo, tutto è nulla, cifra inconfondibile del singolare romanzo-saggio del 1972, fino dal movimento d’avvio:
Nella vita degli imperatori c’è un momento che segue all’ampiezza dei territori che abbiamo conquistato, alla malinconia e al sollievo di sapere che presto rinunceremo a conoscerli e a comprenderli; un senso come di vuoto che ci prende una sera con gli odori degli elefanti dopo la pioggia e della cenere di sandalo che si raffredda nei bracieri; una vertigine che fa tremare i fiumi e le montagne istoriati sulla fulva groppa dei planisferi, (…) è il momento disperato in cui si scopre che quest’impero che ci era sembrato la somma di tutte le meraviglie è uno sfacelo senza fine né forma, che la sua corruzione è troppo incancrenita perché il nostro scettro possa mettervi riparo.[7]
È in quell’attimo terribile che si profila il potere conoscitivo della parola letteraria:
Solo nei resoconti di Marco Polo, Kublai Kan riusciva a discernere, attraverso le muraglie e le torri destinate a crollare, la filigrana d’un disegno così sottile da sfuggire al morso delle termiti.[8]
Si direbbe di poter cogliere in questi primi passaggi delle Città invisibili riconoscibili echi nietzschiani, in particolare di Così parlò Zarathustra:
Ecco, non c’è sopra né sotto! Slanciati e vola: in giro, in avanti, all’indietro, tu che sei lieve! Canta! (…).
Come potrei sopportare di essere uomo, se l’uomo non fosse anche poeta e solutore di enigmi e redentore della casualità![9]
Resta il fatto che il nome di Nietzsche è sostanzialmente assente nelle pagine calviniane di saggistica o di critica militante e nelle rare occasioni in cui si incontra, nel corso degli anni Quaranta/Cinquanta, è sempre in una accezione sostanzialmente negativa.
È il caso della recensione al volume di Carlo Levi, Paura della libertà, sull’ “Unità” del 15 dicembre 1946:
Il concetto primo dell’esperienza del Levi è il senso del sacro, senso oscuro e anonimo ch’egli vede in fondo a ogni manifestazione umana. Contrapposto al sacro è il religioso, cioè la relegazione di questo senso informe e indefinibile, in una formula, in un simbolo, in un mito, in qualcosa di preciso, di concreto, perciò di falso e innaturale. La concezione del Levi gioca sulla dialettica di questi due termini: il sacro generatore della libertà, dell’arte, della sua anarchia individualistica e barbarica, dell’amore sacro, narcisistico e solitario, e il religioso, generatore della tirannide, della schiavitù, della guerra, del sacrificio agli dèi (che poi diventa nella religione dello stato-Dio sacrificio di una parte della società, classe o razza, dei popoli nemici, dei propri eserciti consacrati alla morte).[10]
Subito dopo un veloce richiamo a Nietzsche:
Paura della libertà non manca di belle pagine saggistiche, di ingegnose interpretazioni storiche, morali, e perfino filologiche. Ma dal libro si comprende qual’è la posizione del Levi nella cultura d’oggi: un uomo d’interessi e d’esiti moderni ma di sensibilità sorpassata, reazionaria. È un anarchico non nel senso bakuniniano, kroptokiniano della parola, ma nel senso tumultuoso ed estetizzante del Nietzsche.[11]
E a rincarare la dose:
Alle volte sembra che solo il caso, solo certi divari nelle impostazioni di partenza l’abbiano portato a militare dalla parte in cui ha valorosamente combattuto, ché il suo gusto, la sua forma-mentis è legata a quella cultura irrazionalista mistico-barbarica che caratterizzò la parte avversaria.[12]
Il giudizio negativo del primo Calvino nei confronti di Nietzsche non potrebbe essere più tagliente.
A distanza di un decennio, nel contributo per “Il Contemporaneo” del 4 giugno 1955, Manniano all’incontrario, si registra tuttavia un sia pur sfumato mutamento di registro:
Noialtri giovani che cominciammo a dichiararci per la narrativa tutta fatti, oggettiva, rapida, “parlata”, se avevamo bisogno di trovare progenitori ponderosi e onesti di dottrina per la nostra rozza incondita schiatta, saremmo andati a tirar giù fin la barba di Tolstoi, o magari anche la papalina di Flaubert, o addirittura i polsini di pizzo di Diderot, ma non mai il colletto inamidato di quest’ultimo campione della narrativa classica e dell’intellettualismo europeo, che appariva estraneo alle nostre preoccupazioni contenutistiche e linguistiche come l’abitante d’un altro pianeta.[13]
Segue la confessione di una correzione del punto di vista riguardo all’autore della Montagna incantata:
Più tardi, guardandoci intorno inquieti, insoddisfatti, con il desiderio d’una letteratura che dicesse di più, che “sapesse” di più sull’uomo d’oggi e la sua condizione storica, col bisogno di venire a capo di mezzo secolo d’esperienze letterarie, ci ritrovammo dinanzi quella sua minuta ragnatela che pareva tesa apposta per noi, con la storia culturale del mezzo secolo masticata dalla sua bocca impassibile, assimilata e sdipanata come un esatto sottilissimo filo tra Serenus Zeitblom, Adrian Leverkuhn, l’estetismo, Nietzsche, Goethe, Savonarola, e i bombardamenti a tappeto. Cominciammo a capire che Mann era un punto di riferimento necessario, da cui non potevamo prescindere. E nel suo sguardo di borghese classico e razionale fisso a scrutare ostinatamente i meandri del decadentismo e dell’ irrazionalismo, quasi fino al punto di immedesimarsi in essi, ma poi sempre restando “altro” da essi, frapponendo fra quelli e sé la lente del distacco storico, della classicità del linguaggio, dell’ironia del grande narratore, trovammo un esempio contemporaneo di come lo scrittore d’un’epoca di transizione e dramma può vivere il vecchio e il nuovo insieme, può partecipare della totalità del dramma pur restando se stesso, giudice e orchestratore supremo.[14]
È di tutta evidenza che Thomas Mann si configuri qui come autore / schermo attraverso cui far passare la ‘impraticabilità’ di una letteratura engagée nei modi in cui si continuava a proporla nella narrativa italiana degli anni Cinquanta:
È giustificabile in un uomo d’oggi questo saper tutto, questa coscienza e quasi compiacimento della tragedia, e poi questo tenersi sempre un po’ fuori, al di sopra, altero, intatto, olimpico, senza contaminarcisi, senza lordarcisi di sangue, fango e lacrime?[15]
La risposta non lascia spazio al dubbio: «È uno scrittore più impegnato dunque quanto più pare maneggi con guanti d’amianto la crisi della sua propria cultura».
E subito dopo la confessione: «Tutta la mia vita è stata un riconoscere validità a cose cui avevo detto “no”».[16]
L’ammissione di un ribaltamento del punto di vista che potrebbe estendersi allo stesso atteggiamento nei confronti del pensiero di Nietzsche.
Non è trascurabile in questa direzione che tra i libri acquistati nel soggiorno a Parigi tra il 1967 e il 1980, conservati nella biblioteca della sua abitazione romana, sia presente un testo di Nietzsche, pubblicato nel 1967 nelle edizioni Pauvert, in cui annotazioni a matita confermano una non distratta lettura: è L’Antéchrist. Anathème contre le christianisme, di cui dà notizia Laura di Nicola nel saggio I libri di Italo Calvino nel fascicolo n° 3 del “Bollettino di italianistica” 2013.
L’idea centrale dell’Anticristo, il primo degli scritti postumi che Nietzsche ha lasciato pronti per la stampa, è che i grandi spiriti siano degli scettici: «La libertà da ogni specie di convinzioni, il saper guardare liberamente (…). L’uomo di fede, il “credente” di ogni specie è necessariamente un uomo dipendente».[17]
Nietzsche stabilisce una perfetta equazione tra il cristiano e l’anarchico:
Il loro scopo, il loro istinto sono rivolti unicamente alla distruzione. (…).
Ciò che esisteva aere perennius, l’imperium romanum, la più grandiosa forma d’organizzazione – in mezzo a difficili condizioni – che sia mai stata raggiunta fino a oggi, a confronto con la quale tutto quanto la precedette, tutto quanto le venne dopo è frammento, abborracciatura, dilettantismo – questi santi anarchici si sono fatti un “pio dovere” di distruggerla, di distruggere “il mondo”, cioè l’imperium romanum, finché non ne restò pietra su pietra – finché gli stessi Germani e altra gente rozza non poterono divenirne padroni.[18]
E in chiusura la sferzante accusa:
La Chiesa cristiana (…) ha fatto di ogni valore un disvalore, di ogni verità una menzogna, di ogni onestà un’abiezione dell’anima. Si osi ancora parlarmi dei suoi benefici “umanitari”! L’eliminazione di una qualsiasi penosa condizione andava contro il suo più profondo vantaggio: essa viveva di condizioni penose, essa creava condizioni penose per eternizzare se stessa… .[19]
Quindi l’invito a passare oltre:
Computiamo il tempo da quel dies nefastus con cui ebbe inizio questa fatalità – dal primo giorno del cristianesimo! – E perché non invece dal suo ultimo giorno? – Da oggi? – Trasvalutazione di tutti i valori!…. .[20]
Le annotazioni di Calvino, leggibili nella copertina del testo nietzschiano conservato nella biblioteca della sua abitazione romana, sono relative esclusivamente al saggio introduttivo di Dionys Mascolo, un intellettuale éngagé il cui quesito iniziale recita: «Qu’en est-il aujourd’hui de la réalité de la mort de Dieu – réalité à la découverte définitive de laquelle Nietzsche dévoua sa vie?».[21]
Convinzione di Mascolo è che Marx, Freud e Nietzsche costituiscano il punto d’incontro decisivo delle nuove esigenze affacciatesi all’inizio del Novecento:
L’entreprise de Nietzsche vise à dégager l’homme réel de l’homme idéal (Crépuscule des idoles) sous lequel il n’est pas seulement “dissimulé”: sous lequel il étouffe. Il n’est pas contestable que son effort va dans le même sens que celui de Marx, et que plus tard celui de Freud. Chez tous trois il s’agit de mettre à jour les forces non seulement invisible, mais incoscientes, ou qui ne sont pas spontanément objet de pensée, et qui jouent à plein, sous d’autres apparences, dans la societé, la conscience individuelle, ou la pensée théorique.[22]
Sottolinea Mascolo che nonostante si tratti di un testo minore di Nietzsche, nondimeno notevole è lo spessore teorico:
Il faut voir cependant cet écrit comme l’oeuvre où vingt ans de méditation généreuse et grave se ramassent et dirigent, avec une brutalité toute “politique” en effet, la plus grande énergie de pensée qu’un homme ait peut-être jamais laissé s’accumuler en lui, contre le personnage et le mythe qui ont, pendant dix-neuf siècles, en Occident, détourné vers un divin nommé, classé, reconnu, toute espèce de sens du sacré (dans le style provocant de L’Antechrist: “Deux mille ans presque, et pas un seul nouveau Dieu!”), rejetant au profane toutes les activités humaines, à commencer par celle de l’esprit, et cela signifie: retirant à l’avance à toute “vérité” possible la pointe de vraie qui lui eût permis d’être vraie.[23]
Se è preclusa l’acquisizione di una verità assoluta tuttavia irrinunciabile è la ricerca, l’infinito interrogare:
Ce qu’il cherchait – non pas la possession de la vérité – non pas connaître – mais plutôt la possibilité de questionner toujours plus avant, les moyens de rouvrir indéfiniment une interrogation que les progrès de la recherche eux-mêmes tendent sans cesse à fermer de conclusions, de réponses – il devait constater que l’existence du christianisme avant toute autre chose y faisait obstacle à chaque pas. Ou que c’était dans le christianisme que toutes les forces opposées à cette recherche puisaient sans cesse à nouveau réconfort et vigueur. Et cela, même “de notre temps”, qui pourtant est “un temps qui sait”. (…).
Et d’abord, le propre du christianisme, ce qui fait de lui, parmi toutes les religions, celle qui corrompt le plus profondément le sens de toutes les oeuvres humaines, du travail à l’amour, c’est qu’il suppose l’intervention directe de la transcendance dans l’histoire.[24]
L’attenzione di Calvino si ferma in particolare sull’ultima parte della presentazione di Mascolo:
Lorsque, dans l’Antechrist, Nietzsche en vient à parler du Dieu dégenéré de la conception chrétienne, tout comme lorsqu’il parle de décadence ou exalte l’antiquité, tout perspectivisme à part, il simplifie sa pensée jusqu’à l’absurde, par le mouvement chez lui si fréquent qui est le mouvement rhétorique de la provocation, dont l’exemple sans équivoque est sa préférence affirmée pour Bizet, qu’il ne faut pas “prendre au sérieux”. Mais toutes les pensées qui s’appuient sur des notions comme celles de dégénérescence, de décadence ou de déclin sont condamnées à la même vanité.[25]
E riguardo al tema dell’oltre-uomo:
C’est à Zarathustra que Nietzsche confie la mission d’enseigner le surhumain. Et souvent par la suite il citera Zarathoustra comme un autre; son envoyé, son héraut, mais un autre.
Nietzsche quant à lui ne tendit jamais qu’à restaurer l’innocence. Que cette exigence ne soit pas dans son oeuvre la plus manifeste ne doit pas nous détourner d’apercevoir qu’en elle est son exigence la plus profonde. On ne peut s’enterdire de penser quelquefois que l’éternel retour lui-même est moins fait pour “donner l’éternité à la moindre chose” que pour écarter de de toute chose quelque finalité que ce soit, pour en finir avec la finalité du monde.
L’innocence du devenir, telle pourrait être sa pensée dernière. Pensée plus difficile, plus “nihiliste”, moins rassicurante même à beaucoup d’égards que celle de l’éternel retour. (…). Elle désigne en effet (…) une sorte de perfectibilité sans espoir, une toute autre espèce de travail, dans un espace non plus orienté (toute direction, toute dimension perdant vigueur), mais voué. à mesure qu’il sera exploré, à devenir de plus en plus incertain et de plus en plus vierge. Nous sommes, depuis la naissance d’une conscience dans le monde, les premiers hommes innocents. Il serait vain de chercher trace de modernité où cette innocence n’est pas pleinemet vécue comme telle.[26]
Quindi il tassativo invito:
Nous n’avons à retenir de Nietzsche finalement que sa négativité. Nous ne connaissons le vrai que comme le contraire d’un non-vrai réel et vivant. Nous ne savont ce qu’est l’homme. Mais nous savons ce qu’il ne doit pas être, ce que nous ne pouvons plus admettre qu’il soit. Nous ne savons de même ce qu’est le monde; nous savons que nous ne pouvons plus admettre aucune des sens dont on a tenté de le charger. Nous n’apercevons aucune issue à notre vie dans ce monde. Comprendre serait l’issue: comprendre est comprendre qu’il n’y a pas d’issue, et comprendre est la seule issue. (…).
L’absence d’issue est sans cesse trahie: l’une de nos “raisons de vivre” est de préserver cette absence d’issue.[27]
Segue un approssimativo raccordo tra l’idea nietzschiana dell’oltre-uomo e la teorizzazione di Marx di una società senza classi:
Si le mouvement communiste – la révolution égalitaire amorcée – étais dans le monde non seulement la seule force capable de venir à bout du mensonge religieux (le mouvement communiste pourrait être en lui-même les “cent Voltaire, cent Sade, cent Nietzsche” dont l’absence désespère) – mais encore la seule capable de réaliser quelche chose de la pensée profonde de Nietzsche, puisque l’homme souverain, cessant de s’épuiser en luttes mesquines pour sauver d’abord les conditiones nécessaires de toute souveraineté, ne pourra de toute évidence vivre pleinement cette souveraineté que comme citoyen de la societé sans classe – il n’y aurait pas là motif à scandale, si ce n’est, à très courte vue, pour les historiens des systèmes clos de pensée.[28]
Recita l’explicit della presentazione: «L’esprit moderne, l’innocence du négatif, respire déjà dans le monde, ce monde ancien où nous sommes toujours».[29]
Senza alcun dubbio Calvino deve aver ritenuto stimolante la lettura del testo nietzschiano proposta dall’intellettuale francese e tuttavia, nelle sue pagine di saggistica e critica militante degli anni parigini e quindi romani (1967 – 1985), mantiene un rigoroso riserbo nei confronti del filosofo tedesco il cui nome torna nella sua riflessione sull’arte soltanto una volta, in parentesi, nel corso di una veloce nota autobiografica, Una lettera in due versioni, indirizzata nel 1969 a Franco Maria Ricci, editore del volume Tarocchi:
Passai i primi venticinque della mia vita nell’a quei tempi ancora verdeggiante San Remo, che univa apporti cosmopoliti ed eccentrici alla chiusura scontrosa della sua rustica concretezza; dagli uni e dagli altri aspetti restai segnato per la vita. Poi mi tenne Torino operosa e razionale, dove il rischio d’impazzire (come già per Nietzsche) non è minore che altrove.[30]
Se si tiene nel debito conto che negli anni Sessanta / Settanta si assiste a livello europeo a una radicale “rilettura” dell’opera di Nietzsche, il silenzio di Calvino è in qualche misura sorprendente, quanto meno in contrasto con quanto egli stesso confessa nel corso della sua ultima intervista rilasciata a Maria Corti nell’estate 1985: «È abbastanza naturale che le idee in circolazione mi abbiano influenzato, talora tempestivamente, talora con ritardo».[31]
E subito dopo, sollecitato dalla sua intervistatrice: «Cambio di rotta per dire qualcosa che con l’impostazione precedente non sarei riuscito a dire».
È di fatto assai probabile che il pensiero del filosofo tedesco abbia esercitato un ascendente niente affatto trascurabile nella sua produzione e narrativa e saggistica degli anni Settanta / Ottanta.
In explicit del racconto del 1973, La taverna dei destini incrociati, nella stessa definizione del Punto come “Il minuto secondo che indica la totalità dei punti contenuti nell’universo”, può riconoscersi l’ascendenza della immagine nietzschiana dell’Attimo: «In ogni attimo comincia l’essere; attorno ad ogni “qui” ruota la sfera “là”. Il centro è dappertutto».[32]
E in uno dei suoi più autentici autoritratti in Il Castello dei destini incrociati: «Un giocoliere o un illusionista che dispone sul suo banco da fiera un certo numero di figure e spostandole, connettendole e scambiandole ottiene un certo numero di effetti», risuona distintamente l’eco del Canto della melanconia di Così parlò Zarathustra:
Un pretendente della verità, sei tu?
(…)
No! Giullare soltanto! Soltanto poeta!
Uno che dice solo parole variegate,
Che strilla variegato da larve di giullare,
Che sale su per ponti menzogneri di parole,
Per variegati arcobaleni,
Tesi tra cieli falsi
E false terre,
Equilibrista girovago. –
Giullare soltanto! Soltanto poeta!
Senz’altro in linea con il pensiero di Nietzsche la fede insistentemente professata dall’ultimo Calvino nel potere conoscitivo della parola letteraria: «La parola collega la traccia visibile alla cosa invisibile, alla cosa assente, alla cosa desiderata o temuta, come un fragile ponte di fortuna gettato sul vuoto».
E se anche quel fragile ponte sul vuoto dovesse configurarsi come un ponte “proteso” verso il vuoto, la “Letteratura” conserverebbe intatta la funzione di unico argine, di unica, possibile Terra Promessa.
Nell’ultima delle microcornici delle Città invisibili, a Kublai Kan che, mostrando a Marco Polo un Atlante in cui sono raffigurate le carte delle terre promesse, dalla Nuova Atlantide a Utopia, alla Città del Sole, a Oceana, a Tamoé, a Armonia, a New-Lanark, a Icaria, gli chiede: «Tu che esplori intorno e vedi i segni, saprai dirmi verso quale di questi futuri ci spingono i venti propizi?», la risposta del veneziano recita:
Per questi porti non saprei tracciare la rotta sulla carta né fissare la data dell’approdo. Alle volte mi basta uno scorcio che s’apre nel bel mezzo d’un paesaggio incongruo, un affiorare di luci nella nebbia, il dialogo di due passanti che s’incontrano nel viavai, per pensare che partendo di lì metterò assieme pezzo a pezzo la città perfetta, fatta di frammenti mescolati col resto, d’istanti separati da intervalli, di segnali che uno manda e non sa chi li raccoglie. (…).
Se ti dico che la città cui tende il mio viaggio è discontinua nello spazio e nel tempo, ora più rara ora più densa, tu non devi credere che si possa smettere di cercarla.[33]
Soltanto nello spazio della Letteratura può configurarsi la città discontinua, frammentata, pulviscolare, alla quale accenna Marco Polo.
In questa direzione sovviene l’analisi che nella penultima delle Lezioni americane Calvino dedica al celebre racconto Le chef-d’oeuvre inconnu di Balzac il cui protagonista, il pittore Frenhofer, dopo anni di furibondo lavoro spesi a eseguire il ritratto della Belle Noiseuse, non riesce a creare che una massa informe di pasta colorata dalla quale emerge soltanto un piede diafano, come un frammento di statua sopravvissuto alla distruzione di una città, a testimoniare che il genio artistico è un’energia attimo per attimo scattante sotto l’impulso di un sentimento efficace, e non una perpetua, increata, irrelativa matrice sempre pronta a generare, dal nulla, una popolazione di poetici fantasmi:
La fantasia dell’artista è un mondo di potenzialità che nessuna opera riuscirà a mettere in atto; quello di cui facciamo esperienza vivendo è un altro mondo, che risponde ad altre forme di ordine e di disordine; gli strati di parole che s’accumulano sulle pagine come gli strati di colore sulla tela sono un altro mondo ancora, anch’esso infinito ma più governabile, meno refrattario a una forma. Il rapporto tra i due mondi è quell’indefinibile di cui parlava Balzac: o meglio, noi lo diremmo indecidibile, come il paradosso d’un insieme infinito che contiene altri infiniti.[34]
È da questa presa d’atto che, nella lettura di Calvino, Balzac cambia strategia ma fa salva la coerenza:
Aveva cercato di catturare l’anima del mondo in una singola figura tra le infinite immaginabili; ma per far questo doveva caricare la parola scritta d’una tale intensità che essa avrebbe finito per non rimandare più a un mondo al di fuor di essa, come i colori e le linee del quadro di Frenhofer. Affacciatosi a questa soglia, Balzac s’arresta, e cambia il suo programma. Non più la scrittura intensiva ma la scrittura estensiva. Il Balzac realista cercherà di coprire con la scrittura la distesa infinita dello spazio e del tempo brulicanti di multitudini, di vite, di storie.
(Ma forse è il mondo interiore del Balzac fantastico a includere il mondo interiore del Balzac realista, perché una delle infinite fantasie del primo coincide coll’infinito realistico della Commedia umana…).
Si direbbe che in quest’ultima annotazione, in parentesi e in forma dubitativa, Calvino rilasci una dichiarazione in primo luogo a chiarezza di sé, del suo stesso “essere scrittore”.
In questa direzione un suo scritto autobiografico, Sotto quella pietra, nel fascicolo di “La Repubblica” del 15 aprile 1980: “Per un certo numero di anni, c’è uno che crede di lavorare alla costruzione di una società attraverso il lavoro di costruzione di una letteratura. Col passare degli anni s’accorge che la società intorno a lui … è qualcosa che risponde sempre meno a progetti o previsioni. E la letteratura è anch’essa refrattaria a ogni progettazione, non si lascia contenere in nessun discorso. Per un po’ il protagonista del libro cerca di tener dietro alla complessità crescente architettando formule sempre più dettagliate e spostando i fronti d’attacco, poi a poco a poco capisce che è il suo atteggiamento di fondo che non regge più. Comincia a vedere il mondo umano come qualcosa in cui ciò che conta si svilupperà attraverso processi millenari oppure consiste in avvenimenti minutissimi e quasi microscopici.” [35]
Emblematico Palomar, l’ultimo romanzo/saggio, la cui sopracoperta, nella prima edizione del 1983 nella collana “Supercoralli” Einaudi, riproduce una incisione di Albrecht Durer, Il disegnatore della donna coricata: una immagine bipartita in cui si fronteggiano una donna nuda e un uomo, armato di penna e mirino, che la guarda attraverso una griglia quadrettata che richiama uno dei sistemi di approssimazione prospettica ideati dai teorici rinascimentali.[36]
Calvino / Palomar decide di inseguire i minimi mutamenti che si verificano sotto il suo sguardo, a cominciare dalla “lettura di un’onda”:
Siccome ciò che il signor Palomar intende fare in questo momento è semplicemente vedere un’onda, cioè cogliere tutte le sue componenti simultanee senza trascurarne nessuna, il suo sguardo si si fermerà sul movimento dell’acqua che batte sulla riva finché potrà registrare spetti che non aveva colto prima; appena s’accorgerà che le immagini si ripetono saprà d’aver visto tutto quel che voleva vedere e potrà smettere.[37]
Insoddisfatto, non esita a cambiare strategia, dall’esterno verso l’interno:
La strada che gli resta aperta è questa: si dedicherà d’ora in poi alla conoscenza di se stesso, esplorerà la propria geografia interiore, traccerà il diagramma dei moti del suo animo, ne ricaverà le formule e i teoremi, punterà il suo telescopio sulle orbite tracciate dal corso della sua vita anziché su quelle delle costellazioni.[38]
Il viaggio mentale in cui si aspetta di “veder navigare in silenzio stelle e pianeti sulle parabole e le ellissi che determinano il carattere e il destino; (…) una sfera di circonferenza infinita che ha l’io per centro e il centro dappertutto”, si configura deludente:
Apre gli occhi: quel che appare al suo sguardo gli sembra d’averlo già visto tutti i giorni: vie piene di gente che ha fretta e si fa largo a gomitate, senza guardarsi in faccia, tra alte mura spigolose e scrostate. In fondo, il cielo stellato sprizza bagliori intermittenti come un meccanismo inceppato, che sussulta e cigola in tutte le sue giunture non oliate, avamposti d’un universo pericolante, contorto, senza requie come lui.[39]
Di qui il tentativo estremo:
Il signor Palomar decide che d’ora in poi farà come se fosse morto (…).
Pensando alla propria morte pensa già a quella degli ultimi sopravvissuti della specie umana o dei suoi derivati o eredi: sul globo terrestre devastato e deserto sbarcano gli esploratori d’un altro pianeta, decifrano le tracce registrate nei geroglifici delle piramidi e nelle schede perforate dei calcolatori elettronici; la memoria del genere umano rinasce dalle sue ceneri e si dissemina per le zone abitate dell’universo. E così di rinvio in rinvio si arriva al momento in cui sarà il tempo a logorarsi e ad estinguersi in un cielo vuoto, quando l’ultimo supporto materiale della memoria del vivere si sarà degradato in una vampa di calore, o avrà cristallizzato i suoi atomi nel gelo d’un ordine immobile.[40]
Inesorabile la deduzione:
“Se il tempo deve finire, lo si può descrivere, istante per istante, – pensa Palomar – e ogni istante, a descriverlo, si dilata tanto che non se ne vede più la fine”.
Decide che si metterà a descrivere ogni istante della sua vita, e finché non li avrà descritti tutti non penserà più d’esser morto. In quel momento muore.[41]
Ciò che salva è “il potere di mettere a fuoco visioni a occhi chiusi, di far scaturire colori e forme dall’allineamento di caratteri alfabetici neri su una pagina bianca”, di “pensare per immagini”.[42]
E in Molteplicità, la lezione che chiude il ciclo delle Lezioni americane: «La mia fiducia nel futuro della letteratura consiste nel sapere che ci sono cose che solo la letteratura può dare coi suoi mezzi specifici».[43]
Da questa angolazione innegabile la sua consonanza con un autore anomalo nel panorama culturale italiano quale è Alberto Savinio dei cui scritti consistente è peraltro la presenza nella biblioteca della sua abitazione romana: Tutta la vita e Narrate uomini la vostra storia, nelle milanesi edizioni Bompiani del ’69 e del ‘77; di quest’ultimo anno anche Torre di guardia, nelle edizioni Sellerio di Palermo; Drammaticità di Leopardi, nelle romane Edizioni della Cometa del 1980 oltre a Infanzia di Nivasio Dolcemare del 1973, Maupassant e l’altro del 1975, Sorte dell’Europa e Nuova Enciclopedia, entrambi del 1977, Il signor Dido del 1978, La nostra anima. Il signor Munster del 1981, Palchetti romani del 1982, Ascolto il tuo cuore, città del 1984, tutti nelle milanesi edizioni Adelphi.
E inoltre: è inimmaginabile che gli sia sfuggita la lettura dei testi saviniani pubblicati nelle edizioni Einaudi, Hermaphrodito del 1974, Scatola sonora del 1977 e Tragedia dell’infanzia del 1978, anche se non sono presenti nella sua biblioteca romana.
C’è di più.
Nel corso di una intervista dell’ottobre 1980, La relève de la garde, rilasciata a Mario Fusco per “Magazine littéraire” 165, riproposta in italiano nel volume a cura di Luca Baranelli, Sono nato in America, edito da Mondadori nel 2012, alla domanda riguardo a quel che caratterizzi la situazione letteraria italiana, Calvino risponde:
In primo luogo il fatto che alcuni autori i quali, venticinque anni fa, erano considerati figure marginali, eccentriche, hanno oggi un’importanza centrale. È il caso di Savinio, che in Italia non è mai stato uno sconosciuto, ma che era sempre rimasto ai margini. In questi ultimi anni è stato ristampato un certo numero di suoi libri; sono stati anche pubblicati molti inediti che hanno contribuito a ridargli evidenza. Savinio è certamente un autore che ha un interesse letterario di prim’ordine; ma è anche rappresentativo dello stato di una letteratura caratterizzata da un insieme di “casi”.[44]
Il disappunto di Calvino per la marginalità in cui l’opera di Savinio è stata relegata fino agli anni Settanta avvalora l’ipotesi di un suo avvicinamento ascrivibile alla seconda metà degli anni Cinquanta, probabile mediatore Elio Vittorini.
Non trascurabile in questa direzione il fatto che lo scrittore siciliano, di cui Calvino riconosce di aver ‘subito’ l’autorità intellettuale fino dai primi anni della collaborazione alla Einaudi, abbia avuto familiarità con la produzione pittorica di Savinio fino dagli anni Trenta, secondo quanto testimonia la sua argomentata recensione Mostre fiorentine. Savinio, pubblicata nel fascicolo del 15 gennaio 1933 di “L’Italia letteraria”.[45]
Scrive Vittorini:
La pittura di Alberto Savinio sarebbe piaciuta agli antichi greci. Non dico che gli antichi greci dipingevano o avrebbero dipinto come Savinio – e non faccio nemmeno questione di qualità della rappresentazione pittorica. Dico che la pittura di Savinio avrebbe trovato il più largo consenso di popolo presso gli antichi greci, in quanto avrebbe soddisfatto quel loro gusto della deformazione che miti e opere letterarie, se non figurative, ci documentano. In chi fantasticava del minotauro, o immaginava Giove sotto forma di toro o di cigno, e in Savinio che vede i suoi personaggi con teste di struzzo, di anitre, caproni e giraffe, il gusto suscitatore è lo stesso. Gusto per il quale la deformazione avviene come simbolo di trasfigurazione. E che il nostro pubblico d’oggi non riesca più a intenderlo è peggio per lui, per il pubblico, perché vuol dire che sta perdendo tutte le sue capacità di comprendere. Ancora un secolo di questo passo, povero pubblico, e si ridurrà a non poter capire che se stesso dentro lo specchio, chiederà alle arti figurative l’assoluta integrità esteriore delle cose, agli scrittori il tutto-parlato, al cinematografo il tutto-rilievo. Beninteso che in Savinio quel gusto opera per via ironica, appunto come negli autori dell’ epoca ellenistica, come in Luciano a cui per scrivere della nascita di Minerva dal cervello di Giove, occorreva il colpo di scure di Vulcano.
Il colpo di scure in Savinio è sottinteso. Non per nulla è pittore di “dopo la guerra”. Perciò egli riesce ironico nel senso più moderno della parola. Ma di spirito intensamente umanistico, ove per umanesimo si sappia intendere una posizione di cultura squisita e raffinata (posizione ellenistica di fronte all’Ellade immensa di tutto il passato, dagli egizi fino a de Chirico).
Si guardino soprattutto i disegni. Di un segno lieve e pur folto, che rende i volumi con una densità di sfumato impalpabile e come in un’atmosfera di cipria, più che “visioni” di cose, si direbbero “associazioni” di idee. Di idee che abbiano preso corpo in cose visibili, idee culturali, magari storiche, magari filosofiche, che abbiano sposato un oggetto qualunque della realtà. Perciò, in fondo, “associazioni” di cose, realistiche nei singoli elementi, allegoriche in sintesi, e in altri termini “visioni” introspettive.
Ecco, ad esempio, la Morte di Cicerone, visto di tergo, è diventato una specie di professore celibe che l’aquila romana assale nel lettuccio sconquassato. C’è la realizzazione figurativa di un concetto e di un momento della memoria; c’è, resa visibile, una realtà mentale. E che importa che non si tratta, invece, di realtà espressamente visiva? (…).
Nelle pitture di Savinio, come nei disegni, è sempre per associazione di idee che le forme di realtà sono cercate. E se qui risulta piuttosto sovrapposto quanto riusciva fuso, per quell’aria di cipria, nei disegni, l’equilibrio tra i vari elementi del quadro viene ristabilito dal colore che, in Savinio, sia pure agendo con forza nient’altro che decorativa ha, in ogni caso, efficacia d’evocazione.
Resta da vedere se grazie a codesto equilibrio, che è realistico, Savinio giunge a farci credere alle sue “associazioni” come a una sua realtà. Vedere questo è vedere fino a che punto Savinio sia pittore. E difatti vediamo, dove ci fa accettare la Sposa fedele dalla testa di struzzo o la Niobe dal becco d’anitra o Creta con quella testa di canguro ma dall’occhio così umanamente malinconico pur nell’ammicco bovino, come e quanto, per la risoluzione realistica del motivo (riduzione in clima attraverso i colori) Savinio è, anche lui, pittore.
La acutezza della interpretazione di Vittorini testimonia una frequentazione dell’opera saviniana non limitata alla pittura.
È assai probabile che Calvino, nel passaggio dagli anni Cinquanta ai Sessanta, approdando a una modalità di racconto trasgressiva nei confronti del realismo, si avvicini per la mediazione di Vittorini alla produzione letteraria e pittorica di Savinio di cui condivide la disincantata, ironica limpidezza di sguardo, la pratica di una scrittura sperimentale, la visione anti-dialettica, il rifiuto dell’antropocentrismo, il ricorso al mito in riferimento all’oggi.[46]
La stessa formulazione di “enciclopedia aperta”, nell’ultima delle Lezioni americane, si direbbe rimandi alla Nuova Enciclopedia di Savinio:
Quella che prende forma nei romanzi del XX secolo è l’idea di una enciclopedia aperta, aggettivo che certamente contraddice il sostantivo enciclopedia, nato etimologicamente dalla pretesa di esaurire la conoscenza del mondo rinchiudendola in un circolo. Oggi non è più pensabile una totalità che non sia potenziale, congetturale, plurima.
A differenza della letteratura medievale che tendeva a opere che esprimessero l’integrazione dello scibile umano in un ordine e una forma stabile di compattezza, come la Divina Commedia, dove convergono una multiforme ricchezza linguistica e l’applicazione d’un pensiero sistematico e unitario, i libri moderni che più amiamo nascono dal confluire e scontrarsi d’una molteplicità di metodi interpretativi, modi di pensare, stili d’espressione. Anche se il disegno generale è stato minuziosamente progettato, ciò che conta non è il suo chiudersi in una figura armoniosa, ma è la forza centrifuga che da esso si sprigiona, la pluralità dei linguaggi.[47]
E in precedenza, nel corso dell’ intervista, Celui qui se tient derrière tous ceux qui écrivent, per “La Quinzaine” del 16-30 aprile 1981, al rilievo di Phlippe di Meo: «Si ha l’impressione che lei abbia voluto fare una sintesi “totale” delle esperienze narrative di questo dopoguerra, la cui metafora sarebbe la cecità di quello che lei chiama il “Padre dei Racconti”, lo scrittore, colui che produce il simbolico e che, in certo modo, mette in opera una materia che gli sfugge»” Calvino ribatte infastidito: «La parola “totalità” non mi piace; diciamo catalogo e anche enciclopedia…»[48]
All’incalzare dell’intervistatore: «Nel senso di Savinio?», risponde senza esitazioni: «Sì, e di tutta quella famiglia di scrittori “enciclopedisti”, da Savinio a Borges, che sono anche persone piene di curiosità e che certo non intendono imporre una visione globale del mondo».[49]
Da Savinio a Borges: è in questa linea che all’ultimo Calvino piace riconoscersi?
Sempre nel 1981, nel supplemento “Cultura” dell’“Avanti!” del 15-16 febbraio, nel corso dell’intervista Con gli strumenti dell’ironia, alla domanda: «Sente familiare il mondo fantastico di Alberto Savinio?», si lascia andare alla confessione: «Io amo molto Alberto Savinio. (…).
Penso che oggi solo una letteratura ironica riesca a far fronte alla terribilità del mondo in cui viviamo».[50]
[1] Questo testo è stato pubblicato in Appendice di Lezioni americane. Ora in I. Calvino, Saggi. 1945-1985, Milano, Mondadori, 1995, pp. 735-753.
[2] I. Calvino, Viaggio nelle città di de Chirico, in Romanzi e racconti, III° vol., Milano, Mondadori, pp. 397-406; Cfr. R. Tordi, Calvino in viaggio nelle città di de Chirico in Cinque Studi, Roma, Bulzoni, 2010
[3] I. Calvino, Visibilità in Lezioni americane, Milano, ed. Oscar Mondadori, 2009, p. 99
[4] Ivi, p. 101
[5] Cfr. M. Belpoliti, Settanta, II° ed, Torino, Einaudi, 2010, p. 223-224.
[6] I. Calvino, Le città invisibili, Torino, Einaudi, 1972; per questo studio si fa riferimento alla pubblicazione nella collana degli Oscar, Milano, Mondadori, 1993, p. 73.
[7] Ivi, p. 5
[8] Ibidem
[9] F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, in Piccola Biblioteca 36, Milano, Adelphi, 1968, p.282 e p. 170.
[10] I. Calvino, recensione al volume di C. Levi, Paura della libertà (Torino, Einaudi, 1946) ora in Saggi, op. cit., p. 1114
[11] Ivi, p. 1115
[12] Ibidem
[13] I. Calvino, Manniano all’incontrario in Saggi, op. cit., p. 1339
[14] Ivi, pp. 1338-1339
[15] Ivi, p. 1340. Il 1967 è il punto di svolta: se nei saggi scritti tra il 1955 e il 1965 prevale una letteratura intesa come progetto sociale e politico, nel 1967 il discorso cambia e diventa apertamente epistemologico e interdisciplinare. Recita il testo di una sua conferenza, Mondo scritto e mondo non scritto, letta alla New York University come “James lecture” all’Institute for the Humanities il 30 marzo 1983: «Appartengo all’ultima generazione che ha creduto in un disegno di letteratura inserito in un disegno di società. E l’uno e l’altro sono saltati in aria».
[16] Ivi, p. 1342
[17] F. Nietzsche, L’anticristo, Milano, Adelphi, 2a ed., 1975, p. 242. Nel frontespizio del manoscritto definitivo è ancora leggibile il sottotitolo Trasvalutazione di tutti i valori, cancellato dall’autore e sostituito da Maledizione del Cristianesimo.
[18] Ivi, p. 252
[19] Ivi, p. 260
[20] Ibidem
[21] D. Mascolo, Introduzione all’edizione francese 1967 di L’Antechrist di F.Nietzsche, p. 10. Traduzione di chi scrive: “Che cosa ne è oggi della realtà della morte di Dio – realtà alla cui definitiva scoperta Nietzsche dedicò la sua vita?”
[22] Ivi, p. 58. Trad.: “L’operazione di Nietzsche mira a svincolare l’uomo reale dall’uomo ideale (Crepuscolo degli idoli) sotto il quale non è soltanto “dissimulato”:. È incontestabile che il suo tentativo va nella stessa direzione di quello di Marx, e più tardi di Freud. Per tutti e tre si tratta di portare allo scoperto le forze non soltanto invisibili, ma inconsce, ovvero che non sono spontaneamente oggetto del pensiero, e che sono pienamente in gioco, sotto altre apparenze, nella società, la coscienza individuale, o il pensiero teorico”.
[23] Ivi, pp. 16-17. Trad.: “È necessario tuttavia considerare questo scritto come l’opera in cui venti anni di meditazione generosa e severa si raccolgono e si orientano, con una brutalità tutta “politica” in effetti, la più grande energia di pensiero che un uomo abbia mai lasciato condensare in sé, contro il personaggio e il mito che hanno, nel corso di diciannove secoli, in Occidente, volta verso un divino nominato, classificato, riconosciuto, ogni specie di senso del sacro (nello stile provocatorio dell’Anticristo: “Quasi duemila anni, e non un solo nuovo Dio!”), respingendo tra ciò che è profano tutte le attività umane, a cominciare da quelle dello spirito, e ciò significa: togliere a priori a ogni “verità” possibile la parte di verità che gli avrebbe permesso di essere vera”.
[24] Ivi, pp. 49-50. Trad.: “Tuttavia Nietzsche “voleva” – cercava qualcosa. Quel che cercava – non il possesso della verità – non conoscere – ma piuttosto la possibilità di spingere la questione sempre più avanti, i mezzi per riaprire all’infinito una interrogazione che gli stessi progressi della ricerca tendono senza sosta a chiudere con conclusioni, risposte – doveva constatare che l’esistenza del cristianesimo prima di ogni altra cosa poneva ostacoli a ogni passo. Ovvero che era nel cristianesimo che tutte le forze contrarie a questa ricerca spingevano senza sosta a un nuovo riconforto e vigore. E ciò, persino nel “nostro tempo”, nonostante sia “un tempo che sa”. (…).
E ancora, ciò che è proprio del cristianesimo, che fa di esso, tra tutte le religioni, quella che corrompe al massimo della profondità il senso di tutte le opere umane, dal lavoro all’amore, è dovuto al fatto che presuppone l’intervento diretto della trascendenza nella storia”.
[25] Ivi, p. 54-55. Trad.: “Allorché, nell’Anticristo, Nietzsche arriva a parlare del Dio dégéneré della concezione cristiana, così come quando parla di décadence o esalta l’antichità, a parte ogni prospettiva, semplifica il suo pensiero fino all’assurdo, a causa dell’atteggiamento così frequente in lui che è quello retorico della provocazione, di cui inequivocabile esempio è la sua preferenza dichiarata per Bizet, che non bisogna “prendere sul serio”. Ma tutti i pensieri che poggiano su nozioni come quelle di degenerazione, decadenza o declino sono condannati ad essere ugualmente vani”.
[26] Ivi, pp. 64-65. Trad.: “È a Zarathustra che Nietzsche affida la missione di insegnare l’oltreumano. E spesso in seguito citerà Zarathustra come un altro; il suo inviato, il suo eroe, ma un altro.
Nietzsche di fatto non tende che a restaurare l’innocenza. Che questa esigenza non sia nella sua opera la più manifesta non deve distoglierci dall’intendere che è quella la sua esigenza più profonda. Non si può non capire che lo stesso eterno ritorno non è in funzione del “donare eternità alla cosa più piccola” ma piuttosto per sottrarre ogni cosa a una qualunque finalità, per finirla con la finalità nel mondo. L’innocenza del divenire, questo potrebbe essere il suo pensiero ultimo. Pensiero più difficile, più “nichilista”, meno rassicurante da molti punti di vista persino di quello dell’eterno ritorno, qualunque senso ci i spinga a dare ad esso, e di tutti, quello che concede il minimo riposo. Esso designa in effetti, non più un qualunque fine, né alcun senso, e nemmeno la semplice assenza di speranza, e nemmeno questa ragione – questo fine – che è ancora a suo modo la prova (il Giudizio) dell’eterno ritorno, una sorta di perfettibilità senza speranza, una del tutto diversa specie di lavoro, in uno spazio non più orientato (ogni dimensione, ogni direzione, perde vigore), ma votato, una volta che sarà esplorato, a diventare sempre più incerto e vergine. Noi siamo, dalla nascita di una coscienza nel mondo, i primi uomini innocenti. Sarebbe vano cercare traccia di modernità dove questa innocenza non sia pienamente vissuta come tale”.
[27] Ivi, pp. 68-69. Trad.: “Non dobbiamo infine condividere altro di Nietzsche che il suo pensiero negativo. Non conosciamo il vero se non come il contrario del non-vero reale e vivente. Non sappiamo che cosa sia l’uomo. Ma sappiamo ciò che non deve essere, ciò che non possiamo accettare che sia. Non sappiamo nemmeno che cosa sia il mondo; sappiamo che non possiamo accettare alcun senso di quelli di cui si è tentato di caricarlo. Non riconosciamo alcuno scopo alla nostra vita in questo mondo. Comprendere sarebbe lo scopo: comprendere è comprendere che non c’è scopo, e comprendere è il solo scopo. (…).
L’assenza di scopo è tradita senza posa: una della “ragioni di vivere” è di preservare questa assenza di scopo. Tutto è da perseguire, in questo senso: dobbiamo respingere ciò che si dà per vero, vero limite – per distruggere “le cose come sono”.
[28] Ivi, p. 70. Trad.: “Se il movimento comunista – la rivoluzione egualitaria avviata – fosse nel mondo non soltanto la sola forza capace di venire a capo della menzogna religiosa (il movimento comunista potrebbe essere di per sé i “cento Voltaire, cento Sade, cento Nietzsche” la cui assenza è motivo di grande afflizione) – ma ancora la sola capace di realizzare qualcosa del pensiero profondo di Nietzsche, poiché l’uomo sovrano, cessando di impegnarsi in lotte meschine per salvare ancora le condizioni necessarie di ogni sovranità, non potrà con ogni evidenza vivere pienamente questa sovranità che come cittadino di una società senza classi – non ci sarebbe motivo di scandalo, se ce n’è, a guardare da vicino, per gli storici dei sistemi di pensiero chiusi”.
[29] Ivi, p. 72. Trad.: “Lo spirito moderno, l’innocenza del negativo, respira già nel mondo, questo mondo antico in cui sempre siamo”.
[30] I. Calvino, Lettera in due versioni in Saggi. Op. cit., pp.737-753; già in uno scritto del 1960, Lo scrittore e la città, (Saggi, op.cit. p. 2708) Calvino: “Torino è una città che invita (…) alla logica, e attraverso la logica apre la via alla follia”.
[31] M. Corti, Intervista a Italo Calvino, in “Autografo”, ottobre 1985, p. 48; ora in Saggi, op. cit., vol. II°, p. 2920-‘29. È degli anni Sessanta l’edizione critica dell’Opera omnia di Nietzsche a cura di G. Colli e M. Montinari per l’editrice milanese Adelphi.
[32] F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, op. cit., p. 266. Si confronti anche La visione e l’enigma (p.191): «Guarda questa porta carraia! (…). Due sentieri convergono qui: nessuno li ha mai percorsi fino alla fine.
Questa lunga via fino alla porta e all’indietro: dura un’eternità. E quella lunga via fuori della porta e in avanti – è un’altra eternità.
Si contraddicono a vicenda, questi sentieri; sbattono la testa l’un contro l’altro: e qui, a questa porta carraia, essi convengono. In alto sta scritto il nome della porta: “attimo”».
[33] Cfr. il contributo di Calvino per la rivista “Nuova società”, fasc. III° del 1975, con il titolo che, riferito alla città, recita Deve ritrovare i suoi dei, titolo che poi diventa Gli dei della città in Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, Torino, Einaudi, 1980, pp. 282-285. Sulla natura antagonistica del confronto di Calvino con la tradizione utopica, il saggio di C. Milanini nel primo fascicolo del Bollettino di italianistica 2013, p. 42
Cfr. il passaggio di un testo calviniano del 1974, di fatto ancora inedito, che Milanini riporta a pag. 47 del suo saggio nell’ultimo Bollettino di italianistica: «La fortuna dell’utopia ha avuto un momento di ritorno di fiamma negli anni intorno al ’68, quando sembrava che tutto fosse rimesso in discussione e si dovesse riimmaginare su scala mondiale una società futura. Oggi forse le cose si sono ridimensionate e il mondo che ci circonda è sempre meno vivibile, meno accettabile; è in uno stato di avanzata disgregazione. Ma il ricorso all’utopia sembra ancora più lontano, più impossibile. Come arrivare a un mondo completamente diverso? (…). Un particolare interesse hanno gli articoli sull’architettura(…): l’architettura che è stata, nel nostro secolo, una specie di grande religione utopica, che proponeva un’immagine non solo di città, ma di società diversa, e che in varia misura ha perduto queste illusioni e che oggi continua a recuperare l’utopia, ma come immagine fantastica, come una polemica contro la città di oggi, immaginando delle città irrealizzabili ma che comunque servono per il loro contrasto con il teatro delle nostre vite attuali (…).
È un po’ in questo senso che nei miei scritti recenti, particolarmente nelle Città invisibili, che parte un poco, appunto, da questa crisi dell’utopia – un fantastico impero di un ipotetico Kublai Kan, che è arrivato a tal punto di sgretolamento, di corruzione, di putrefazione, per cui anche un suo risanamento appare quasi impossibile – c’è il desiderio di cogliere delle immagini che si salvino da questa disgregazione e che in questo momento ci appaiono solo frammentarie e quasi polverizzate».
[34] I. Calvino, Visibilità in Lezioni americane. op. cit. pp. 108-109. Il sottotitolo del racconto di Balzac nella prima edizione recita: Conte phantastique.
[35] La citazione è ripresa dal saggio di G. Patrizi, Calvino e la cultura francese post-strutturalista nel fascicolo di dicembre 2014 di “L’Illuminista”, pp. 153-154.
[36] I. Calvino, Palomar, Torino, Einaudi, !983; ora in Romanzi e Racconti, vol.II°, I Meridiani, Milano, Mondadori, 1992
[37] I. Calvino, Lettura d’un onda, in “Corriere della sera”, 24 ag. 1975: ora in Palomar, op. cit., p. 876
[38] Ivi, p. 974
[39] Ibidem
[40] Ivi, p.976
[41] Ivi, p. 979
[42] Ivi, p.103
[43] Cfr. M. Belpoliti, L’occhio di Calvino, op. cit., p. XIV
[44] I. Calvino, Il cambio della guardia in Sono nato in America, Interviste 1951-1985, introduzione di M. Barenghi, Milano, Mondadori, 2012, p. 376. La risposta di Calvino prosegue con la seguente annotazione: «Bisogna anche dire che ha assunto un’importanza crescente una corrente, quella di una letteratura d’ispirazione grottesca, bizzarra, caratterizzata da elementi fortemente ironici, comici, profondamente diversa dal patetismo degli anni ’50. Savinio si rifà a questa vena».
[45] E. Vittorini, Mostre fiorentine. Savinio, in “L’Italia letteraria”, 15 gennaio 1933. L’articolo è riproposto da Pia Vivarelli in Art Dossier, Firenze, Giunti, 2003, p. 42. Senz’altro intenso il rapporto intellettuale di Calvino con Vittorini il quale muore il 12 febbraio 1966. L’anno successivo Calvino si trasferirà a Parigi fino al 1980 quando deciderà di stabilirsi definitivamente a Roma, in prossimità del Pantheon.
[46] Si pensi al racconto/romanzo saviniano del 1926 Angelica o la notte di maggio dove nella ripresa del mito di Amore e psiche è leggibile il riferimento alla realtà politica italiana segnata dal trasformarsi del movimento fascista in regime.
Calvino condivide l’interesse di Savinio per la musica, il teatro e lo spettacolo. Non è del tutto trascurabile che nel 1981 voglia assistere alla rappresentazione della tragedia mimica saviniana, La morte di Niobe, nel Teatro dell’Opera di Roma.
[47] I. Calvino, Molteplicità in Lezioni americane, op. cit., p. 127. ”.
[48] I. Calvino, Un catalogo di possibilità narrative in Sono nato in America…, op. cit., p.430. Calvino precisa di seguito: “Questo “Padre dei Racconti” è l’iper-romanziere, colui che si mette dietro tutti quelli che scrivono, la voce atemporale e anonima di cui gli scrittori sono gli interpreti: la voce della letteratura, del racconto – non solo scritto ma anche orale – del mito …”.
[49] Ibidem
[50] Ivi p.410. Calvino sente tuttavia la necessità di precisare: “Savinio dice la sua in modo molto libero. Egli non aveva cioè il problema – che io ho sempre dovuto affrontare – della forma narrativa. Scrivere un nuovo libro significa per me costruire una nuova forma di racconto. Savinio quindi è un autore diverso, appartiene a una generazione diversa”.