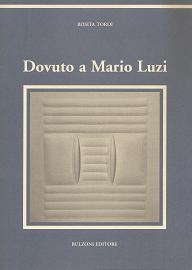Dal volume di Rosita Tordi Castria Dovuto a Mario Luzi, Roma, Bulzoni, 2007, pagg. 9-26:
Luzi e Debenedetti
Anno accademico 1958/’59.
Il corso di lezioni che Giacomo Debenedetti, subentrando a Giuseppe Ungaretti nella cattedra di Letteratura italiana moderna e contemporanea della Università di Roma “La Sapienza”, dedica alla poesia italiana del Novecento, si avvia con un sottolineato richiamo alla riflessione di Mario Luzi sul Simbolismo: “Ebbene lui, l’ermetico Luzi, questo fedele della poetica dell’ermetismo, quando arriva al nodo Baudelaire-Rimbaud-Mallarmé (tralascio, per non complicare la faccenda, gli altri fili che Luzi intreccia a questo nodo), afferma giustamente: ‘Eccoci al centro nevralgico della vicenda’. (…). Insomma bisogna sempre domandarsi, quando si osserva l’ermetismo (una domanda a cui sappiamo che il Luzi, appunto, ha dato una risposta esplicita), fino a che punto i nostri ermetici furono consapevoli, tennero conto in maniera deliberata della poetica dell’arcano e dell’oscuro, quale l’aveva idoleggiata e attuata Stéphane Mallarmé nelle sue Poésies e nelle prose raccolte sotto il titolo di Divagations, quale l’aveva anche teorizzata – se teoria si può chiamare una raffigurazione arcana ed essa stessa ermetica, una trattazione figurata e in aenigmate – in una specie di racconto Igitur e in una specie di trattato Un coup de dés”[i].
Il sonetto di Mallarmé, A’ la nue accablante tu, è il testo/campione scelto dal professore quale termine di confronto per i suoi prelievi nell’ambito della poesia italiana del Novecento: Elegia di Pico Farnese, dalle montaliane Occasioni del 1939, Lago luna alba notte, dalla raccolta ungarettiana del I933 Sentimento del tempo, quindi Nell’imminenza dei quarant’anni, da Onore del vero, la raccolta poetica del 1957 con cui Luzi si apre alle esigenze da cui è sorta, durante e dopo l’ultima guerra, la poesia attenta al vissuto quotidiano e alla storia [ii].
La scelta di una composizione che già nel titolo sembrerebbe testimoniare una resa a quella che Fortini definisce la poesia di un modo ‘cronologico’ di percepire il tempo, offre l’occasione al professore per portare all’evidenza come nel percorso poetico di Luzi non si registrino di fatto autentiche rotture ché a guardar bene finisce sempre per emergere un ancoraggio molto saldo a una concezione poetica tesa a identificare nella precarietà del quotidiano le figure del destino, coerentemente con una scelta di campo, già profilatasi all’altezza degli esordi, con i versi di La barca, la raccolta poetica del 1935.
Recita l’ incipit di Nell’imminenza dei quarant’anni:
Il pensiero m’insegue in questo borgo
cupo ove corre un vento d’altipiano
e il tuffo del rondone taglia il filo
sottile in lontananza dei monti.
Che il borgo, pur descritto con precisione di dettagli, non sia di quelli reperibili in una carta geografica è l’immediato rilievo del professore il quale sottolinea come Luzi abbia ormai acquisito consapevolezza che “anche i momenti immediati della storia – storia degli uomini, storia dell’uomo che la vive in solidarietà anche pratica e attiva con gli altri – possono acquistare una sorta di dignità assoluta, cessare di essere un materiale incidentale, deteriore, accessibile solo al linguaggio della prosa e della cronaca, nominabile solo con quelle che Mallarmé chiamava “le parole della tribù, del gregge”, che è a dire un materiale eterogeneo alla poesia, irriducibile e refrattario all’assoluto della poesia” [iii].
Quel che preme al professore sottolineare è che all’altezza di Onore del vero Luzi continui a cercare ‘il suo bene’ per strade che tuttavia divergono dal comune sentire dei giovani poeti trincerati in una linea di sperimentalismo a oltranza: “Io pensavo di poterle indicare nell’agitarsi e nell’annullarsi della passione individuale in seno alla fenomenologia della natura e dell’umano, nell’agitarsi e nell’annullarsi della volontà individuale in seno alle proposte di un’etica endemica e cioè religiosa, nell’agitarsi e nell’annullarsi del linguaggio individuale in seno alla lingua che contiene, come elementari tesori, i modi del naturale sentire e metaforizzare della gente…” [iv].
Ed è scelta pienamente condivisa dal professore il quale ne evidenzia tutte le difficoltà: “Il linguaggio chiaro, il linguaggio che nomina non può che essere estraneo a queste zone da cui l’io empirico è scomparso. Tali zone per il linguaggio comune sono estranee, sono ermetiche. In sostanza, poesia chiara di un’esperienza che respinge la nomenclatura: poesia chiara di un’esperienza ermetica. Compito della poesia, ormai, è indicare chiaramente la propria vocazione ermetica; constatare attraverso quelle esemplificazioni che sono le singole liriche come “la lingua che esprime il sentire e il metaforizzare comune della gente non può che “alludere” negativamente a ciò che sarebbe esprimibile solo attraverso il linguaggio individuale: negativamente, cioè attraverso la propria incapacità di dire ciò che sarebbe di competenza del linguaggio individuale.
Tanto è vero che l’adozione della lingua comune è paradossalmente simultanea alla rinuncia, all’annichilamento di ciò che la lingua comune è naturalmente nata a battezzare; cioè la passione, la volontà, la storia attiva, documentaria dell’io naturale e psicologico”[v] .
Di qui la singolarità del linguaggio poetico di Luzi all’altezza di Onore del vero: “Quanto alla possibilità – chiosa il professore – di creare dei rapporti tra le singole immagini o apparizioni, tacendone i legami, facendo che quelle immagini o apparizioni si richiamino tra loro come per se stesse mosse, questo non appartiene in proprio alla poesia ermetica: è un carattere di buona e sensibile poesia senza aggettivi”[vi].
E nel chiudere quel corso di lezioni Debenedetti non esita a confessare la propria ‘indisponibilità’ a mettersi in grado di capire o quanto meno di seguire con partecipata attenzione i diversi ‘sperimentalismi’ che si profilano nella scena poetica italiana in quegli ultimi anni Cinquanta: “Certo, il travaglio di conquistarsi un nuovo linguaggio adeguato a una poesia che testimoni la presenza dell’uomo nella storia sociale e civile è stato ed è molto difficile. Proprio per queste ragioni, la poesia nuova, anche quando riesce ad essere poesia, tiene a conservare sempre un atteggiamento di poesia sperimentale” (7).
I corsi universitari successivi di Debenedetti, fino all’ultimo del 1966/’67, saranno dedicati alla narrativa, in particolare a quegli scrittori italiani tra Otto e Novecento, Svevo, Pirandello, Tozzi, i quali, al di là dei tributi pagati al verismo/naturalismo, sono assimilabili a quell’ habitat pienamente europeo che ha luoghi ineludibili di riferimento nell’opera di Joyce e di Proust.
Per molto tempo la mia frequentazione della poesia di Mario Luzi non si è spinta oltre i versi di Onore del vero ai quali ero stata avviata da Debenedetti in quel suo primo corso universitario nell’Ateneo romano.
A distanza di molti anni, in occasione di un convegno a Urbino dedicato a Giuseppe Ungaretti, ho avuto l’opportunità di incontrare per la prima volta Mario Luzi e, con il pretesto di una tesi laurea su Il giusto della vita che stavo seguendo per incarico di Mario Petrucciani, subentrato a Giacomo Debenedetti nella cattedra romana di Letteratura italiana contemporanea, ho richiamato nel corso della breve conversazione quelle lontane lezioni debenedettiane dedicate all’analisi di Nell’imminenza dei quarant’anni (8).
Il ricordo deve essergli stato gradito. Sono seguiti altri incontri di studio nel corso degli anni Ottanta.
Mi ha sorpreso in particolare l’immediatezza con cui Luzi ha accolto nel 1983 l’invito a partecipare al Convegno romano Saba, Trieste e la cultura mitteleuropea, nell’ambito di una ricerca sui rapporti tra poesia italiana e cultura di lingua tedesca nel primo Novecento, diretta da Paolo Chiarini (9).
Il mio Saba, recita il titolo scelto dal poeta per il suo intervento. Ripercorrerlo può aiutare a ricostruire più compiutamente il progressivo aprirsi, negli anni Cinquanta, della sua poesia, costituzionalmente votata a quello che l’autore stesso ha chiamato il “dopotempo”, verso il vissuto personale, il magma dell’esistente, incontrando nei fatti della cronaca un senso diffuso di fallimento e di naufragio.
A proposito di quella stagione poetica scriverà nel 1990 Giovanni Raboni: “L’Italia preindustriale, immobile, in attesa dei colpi di ruspa come un condannato in ginocchio sul patibolo, che ci viene incontro da Primizie nel deserto (pubblicato nel ’52) e da Onore del vero (pubblicato nel ’57) è infinitamente più precisa, più credibile, più vera che in qualsiasi documento d’epoca, in qualsiasi album d’immagini; abbiamo potuto vivere in diretta la sua estatica agonia sulle pagine di quei libri, nel mormorio di quei versi: “La tramontana screpola le argille, / stringe, assoda le terre di lavoro, / irrita l’acqua nelle conche; liscia / zappe confitte, aratri inerti / nel campo …”. E’ difficile, oggi, rendersi conto di quanto peso abbia avuto allora la poesia di Luzi nel far ruotare, nell’organizzare in un nuovo equilibrio il rapporto fra poesia e realtà. Semplicemente, e non certo nei termini ambigui del contenuto ma in quelli inequivocabili della forma, l’alterità lasciava il posto all’integrazione, la sfida al confronto.
Inattaccabile dall’esterno, tetragono alle bordate polemiche degli agit-prop della critica, l’assolutismo lirico di entre-deux-guerres si stemperava, si scioglieva dall’interno, cedendo la sua linfa e la sua energia alla crescita d’un nuovo fervore comunicativo. (…). Negli anni Cinquanta non c’è che Luzi a testimoniarlo compiutamente e pubblicamente, a incarnare la realtà di un trapasso storico che solo la sua generazione poteva vivere come una concreta e necessaria metamorfosi, come un vero e proprio mutamento e adeguamento biologico anziché (sarà il caso di alcuni poeti della generazione successiva, a cominciare da Pasolini) come progetto mentale e dovere ideologico” (10).
E’ allora che Saba si è proposto a Luzi come referente importante. Non è casuale che egli apra il suo intervento al convegno romano confessando un inguaribile senso di colpa per essersi tenuto a lungo a distanza dal poeta triestino: “Devo ammettere che la voce di Saba ha messo parecchio tempo per arrivarmi nella sua pienezza. Una personale mia cronistoria farebbe coincidere quel primo accostamento con la lettura di Uccelli, una breve raccolta del 1951. Il poeta aveva fatto molto cammino, era passato per successive fasi di vita e di stile pur nella sua fondamentale costanza e perfino monotonia. Neppure il suo lettore era rimasto fermo ai suoi primi corollari. La comune sofferenza degli anni appena passati non dico attenuassero le distinzioni naturali e culturali, ma almeno ravvicinavano le distanze che erano sembrate definitive” (11).
Può essere in questa direzione di qualche interesse che la raccolta del 1957, Onore del vero, si apra con la composizione UcceIli il cui incipit recita:
Il vento è un’aspra voce che ammonisce
per noi stuolo che a volte trova pace
e asilo sopra questi rami secchi (12)
dove è leggibile quella “coesistenza di smarrimento esistenziale e di spiritualità religiosa” in cui Debenedetti indicava ai suoi studenti la cifra inconfondibile del dire poetico di Luzi.
“In Uccelli (ma già in Mediterranee) del resto – insiste Luzi nel suo intervento – la poesia di Saba perdeva ciò che mi aveva impedito di sentirla davvero “in causa” e esaltava ciò che anche prima mi era sembrato profondo e incisivo. Perdeva cioè l’elegia minuziosa del proprio caso, la lagna della propria crepuscolare eccentricità e emarginazione, perdeva anche quella sua tendenza a crogiolarsi nelle delizie della norma stilistica, specialmente nei canoni metrici e stilistici dell’introflessione post-leopardiana. Nello stesso tempo liberava nitidamente la potenza che era mescolata e impastata con quelle debolezze. Una certa afflizione personale, scavata, portava in luce un dolore primario, il suo caso poteva profilarsi come un archetipo, il suo essere a parte rifletteva il mitico affanno di un destino persecutore: in quanto alla fedeltà del suo linguaggio a certi schemi e cadenze poteva, in alcuni alti momenti, rappresentare una dolorosa e tormentata esperimentazione linguistica con la profondità e la continuità dell’umano che in quei modi si era espresso: immergere insomma il momento nel tempo antico e ininterrotto.
Di fatto la poesia di Saba è diversa da qualunque altra poesia moderna. Prima di tutto essa non ha per nulla l’aspetto di poesia inventata (lo choc dell’invenzione, dell’ipotesi, dell’associazione immaginativa le è estraneo) e appare piuttosto come una poesia provata in proprio e nello stesso tempo ripassata, in una interminabile ciclicità”.
Essa procede tutta quanta dall’esperienza in corpore vili, dall’analisi del tribolato io, e coglie con grande autenticità scontentezze e rimorsi, inquietudini morali e metafisiche che sono tipiche della situazione moderna ma che essa non mostra per nulla come tali, ma piuttosto come destino, come fato intemporale. Per quanto sensibilità e cultura non neghino a Saba l’intelligenza del tempo moderno, una forma mentis anche più radicata lo dissuade dal rilevare drammaticamente la modernità (come fa appunto la poesia moderna) e lo porta a considerare tutto il male e tutto il bene come sorte unica inalterabile.
Saba sottrae alle emozioni morali e esistenziali ogni carattere provvisorio di novità e regala loro il doppio beneficio dell’infinito atavismo e dell’illimitata ripetizione. Con lui la poesia del nostro secolo viene a contatto con una misura inconsueta: una misura che in parte le toglie euforia e illusione, in parte la esalta abbattendo alla sua visuale la modernità come limite se non forse come coscienza. Ecco perché è così difficile avere lo sguardo limpido nei confronti della poesia di Saba. Forse bisognerà attendere che il mito della modernità istillato alla poesia da Baudelaire e martellato da Rimbaud sia del tutto declinato per leggere bene un autore che quel mito lo ha, non certo per arbitrio, fuso e dissolto. Nella sua umiltà di cronista del “valore eterno” Saba ha tolto alla sua poesia, che esprime appunto la condizione odierna dell’uomo antico con l’uso odierno di strumenti usati e abusati, ha tolto, dicevo, l’euforia ma anche l’umiliazione di dirsi moderna, perché “moderna” è tutto sommato una delimitazione” .
Partire da fatti dell’attualità per scoprirne la ‘illimitata ripetizione’, “immergere il momento nel tempo antico e ininterrotto”, saper essere cronista di ‘valori eterni’ senza ‘accensioni visionarie’: è questo il nucleo dell’insegnamento sabiano elaborato da Luzi con lucida determinazione a partire dalla fine degli anni Quaranta quando ad accendere la sua attenzione nei confronti del poeta triestino è assai probabilmente la pubblicazione nel 1947 di quella particolarissima autoesegesi sabiana che è Storia e cronistoria del Canzoniere ( 13 ).
La mediazione di Debenedetti deve essere intervenuta più tardi e in ogni caso l’incontro diretto si è verificato soltanto negli anni Sessanta, secondo la confessione del poeta: “Sì, l’ho conosciuto, nel ’63-’64, cioè quando si decise a un certo punto a ristampare L’inferno e il limbo per Mondadori. In questa occasione lui era andato a cercare cose mie, letture, scritti anche sparsi e aveva spigolato qualcosa che secondo lui integrava questo volume, e tra l’altro mi ricordo che fece includere in questa seconda edizione delle pagine su D’Annunzio, scritte in occasione della morte di D’Annunzio” (14).
La decisione del critico si direbbe che abbia sorpreso e forse un poco infastidito il poeta che riteneva quelle sue pagine dedicate a D’Annunzio non adeguatamente ‘filtrate’. Sta di fatto che Debenedetti, pubblicando nel 1964 il volume in questione nella collana “La Cultura” della casa editrice Il Saggiatore da lui diretta, è assai probabilmente anche l’autore del breve profilo affidato ai risvolti di copertina: “Si vedrà subito come in questi saggi, non meno illuminanti quando rivelano il dramma del cercare che quando raggiungono la certezza del trovare, risulti feconda, per esempio, l’antitesi inferno–limbo. Essa permette, tra l’altro, di delineare un’interpretazione complessiva, ma tutt’altro che schematica, della letteratura italiana, che appunto “manca di inferno”, con la conseguenza che le difetta anche “il gusto della narrativa”. (…).
Quando fa il critico, Luzi è un critico, e non approfitta dell’occasione per una difesa personale della propria poetica. Semmai, un suo profilo si potrà discernere nella filigrana del saggio Naturalezza del poeta; ma a parte che per lui la personalità del poeta è “riassorbita e quasi invisibile”, i lineamenti che ne lascia trapelare son quelli suscettibili di essere condivisi e che valgono soprattutto come verifica della nozione di poesia, della sorte di questa nel mondo attuale. Alle domande sul senso e i modi di questa sorte, Luzi è tra i più capaci di rispondere, fedele come si serba alle proprie origini ermetiche, ma insieme umanamente e religiosamente pronto ad assolvere i compiti che oggi toccano alla poesia: “vivere nella vita, parlare nella lingua: sicché la sintesi, alla quale l’arte non può rinunziare senza perire, avvenga nella vita, e la sua chiave sia posta nell’umano, qualunque reame debba aprire o rivelare”.
Se la paternità del breve profilo è attribuibile solo in via ipotetica a Debenedetti, senza dubbio sua è la nota editoriale per il saggio del 1962 Lo stile di Constant nella collana delle Silerchie da lui diretta.
Ancora una volta trova qui conferma il temperamento di un critico mai corrivo anche nel redigere una scheda biografica: “Mario Luzi è nato a Castello (Firenze) nel 1914, si è laureato in lettere a Firenze, dal 1938 è insegnante, nel 1935 ha esordito come poeta con la raccolta La barca che segnava “in termini persino troppo scoperti l’emozione di un primo contatto consapevole con la vita”. La filosofia cristiana, la lettura di alcuni grandi scrittori moderni in cui gli era parso di trovare i “veri filosofi” della nostra epoca lo avevano aiutato a precisare la propria vocazione. I presagi ermetici che in quel primo libro affioravano tra le aperture dirette e autobiografiche maturano ne L’avvento notturno, che riunisce la produzione successiva fino al 1940. Nel sostrato ideologico e morale i motivi dello spiritualismo, diffusi anche dalla rivista fiorentina “Il Frontespizio”, erano venuti a contatto col fondamentale cattolicesimo, come risulta anche dal saggio L’opium chrétien (1938). Più tardi, nei tempi della stretta fascista, Luzi collaborerà a “Campo di Marte”, la rivista diretta da Gatto e Pratolini e da lui chiamata “il foglio più ardito dell’ermetismo” (superfluo ricordare i rapporti , in quegli anni e in quel gruppo fiorentino, tra ermetismo e antifascismo). Ma nelle prime raccolte del dopoguerra, Un brindisi (1945) e Quaderno gotico (1947), il poeta poteva constatare come “lo strumento che aveva preparato cominciava a sciogliersi dalla sua stilizzazione e a modificarsi nel movimento”. Memorabile la polemica di Luzi con i poeti sperimentali e “impegnati”, ai quali contrappose una sua diversa partecipazione a un’epoca che chiede agli uomini le loro libere scelte. Primizie del deserto (1952) e Onore del vero (1957) segnano il pieno confluire di una ispirazione tra le più riconoscibili della nostra lirica moderna con linguaggio raggiunto attraverso una splendida coerenza di sviluppi. Nel 1957 Luzi ha condiviso ex-aequo con Saba il premio Marzotto. Nel 1960 ha raccolto sotto il titolo Il giusto della vita le poesie composte fino a quell’anno. A parte va ricordata la prosa di Biografia a Ebe (1942). Le tappe principali di Luzi saggista dopo L’ opium chrétien, sono segnate da Un’illusione platonica e altri saggi ( Firenze 1941), Studio su Mallarmé (ivi 1952), Aspetti della generazione napoleonica e altri saggi di letteratura francese (Parma 1956). Luzi ha inoltre curato un’antologia: L’idea simbolista (Milano 1959), notevole anche per l’introduzione e le note che presentano e collegano i singoli brani. In collaborazione con Tommaso Landolfi, aveva precedentemente pubblicato una Antologie de la lyrique francaise (Firenze 1950). Ha tradotto da Coleridge Poesie e prose (Milano 1949).
Non occorre dire che Mario Luzi è uno dei protagonisti della generazione poetica successiva a quella di Saba, Ungaretti e Montale. Una sua raccolta di saggi e note critiche potrebbe dunque apparire una curiosità offerta ai lettori delle “Silerchie” per completare il ritratto del poeta con qualche esempio di quello che egli fa al di fuori della poesia, in un lavoro che a torto (e lo sa chi conosce L’inferno e il limbo) si chiamerebbe complementare, quasi un “secondo mestiere”. In realtà, questo libretto si aggiunge a una serie di opere critiche ormai considerevole anche per il numero, ma soprattutto intraprese e compiute con adeguata attrezzatura tecnica e culturale, con un metodo che sa quel che vuole, una responsabilità del tutto “professionale”. In altre parole, Luzi non ha bisogno di raccomandarsi come poeta per farsi ascoltare come critico. E se mai, deve a una eccezionale facoltà di esprimersi, superiormente testimoniata dalle sue poesie, la luminosità di certe definizioni, la linea suadente ed emotiva di certi ragguagli sull’intimo di un autore o di un’opera, sicché in lui lo “studio” diventa “saggio”, cioè uno dei più attraenti generi letterari oggi praticati dagli scrittori, punto di confluenza tra una cultura, un pensiero e un temperamento. In più, gli scritti di questa raccolta non hanno bisogno di essere sollecitati per aprire suggestivi spiragli sull’idea che Luzi ha dell’arte in genere e della propria in specie. La presenza di simili spiragli è una delle ragioni che accrescono a questi saggi il diritto di figurare in una collana come le “Silerchie”, la quale d’ora in poi, accanto alle opere “dirette”, si propone anche di dare le “poetiche” dei nostri più interessanti poeti. Se non una esplicita poetica di Luzi, emerge di qui una sua indicazione sul proprio modo di leggere la sua poesia: quello, in ogni caso, che egli sembra augurarsi e a cui destina la proprie liriche. La si troverà, per esempio, nei tratti che identificano, dentro la tessitura dei romanzi e del Cahier rouge di Constant, i punti dove il dato autobiografico si libera in episodi e sequenze di pretto andamento narrativo. Tratti che sembrano alludere a quel rapporto tra autobiografia e invenzione, intensamente sperimentato e risolto da Luzi nella sua attività di artista.
Non meno rivelatrici le pagine che riconoscono la più durevole e convincente poesia di Luoise Labé, dove essa “accoglie gli schemi ideali e formali del proprio tempo, per distruggerli poi con la tensione dei propri affetti. E taluni accenni sul verso della Labé (“acquisisce una quantità esatta di vita, un’energia precisa e sottile, senza ombra di amplificazione e tuttavia ricca di vibrazione e di risonanze segrete”) potrebbero addirittura caratterizzare il verso di Luzi, il sentimento che questo verso ha di se stesso. Anche Luzi d’altronde ha raccolto “schemi ideali e formali” del suo tempo e a essi rimane fedele: sono quelli, com’è noto, dell’ermetismo. E certo non li distrugge ma anche lui riesce di volta in volta a ottenere che “sotto la pressione della sua forza fine e acuta essi si colmino e si tendano”. Anche in lui il sostrato ideale si converte in un vero affettivo”, offrendo l’esempio di “una cultura che diventa natura”. Confidenze tra le righe, identificazioni forse inconsapevoli che, nel riserbo dello scrittore, non corrono mai il rischio di approfittare della critica per contrabbandare spiegazioni personali o, peggio, tessere una personale apologia”.
E’ evidente il gioco di specchi: in quel difficile crinale tra autobiografia e invenzione lo stesso Debenedetti spende la sua avventura di saggista e pratica i suoi mai interrotti commerci con la scrittura creativa di cui sono prova i racconti, in primo luogo Amedeo, del 1924, un racconto lungo assimilabile al genere ‘romanzo di formazione’, e 16 Ottobre 1943, lo straordinario racconto testimonianza della giornata in cui, per ordine del generale Kappler, gli ebrei del ghetto di Roma sono ‘avviati’ ai campi di sterminio.
E inoltre: non è trascurabile che in quel suo corso universitario del 1958 / ’59, subito dopo la lettura di Nell’imminenza dei quarant’anni, il professore abbia preso in esame il sabiano Canto a tre voci, dalla raccolta Preludio e canzonette del 1928/’29, in cui il poeta triestino è principalmente un drammaturgo.
Se è vero che l’interesse di Luzi per l’uso in poesia del dialogo scenico come strumento espressivo privilegiato si profila già a partire dagli anni Cinquanta e perviene ad esiti di notevole originalità nei versi di Presso il Bisenzio con cui si apre la raccolta del 1963 Nel magma, è ipotizzabile che la scelta debenedettiana del Canto a tre voci, proprio in quanto centrata sulle ragioni per cui le situazioni liriche in Saba tendono a condensarsi in personaggi, abbia in qualche misura agito: “Qui non si tratta solo del personaggio del poeta, con la sua storia drammatica o sentimentale, ma dei personaggi esterni che il poeta coglie nella vita e nei quali vede una situazione atta a confessarlo per affinità o per contrasto; più ancora si tratta di una metamorfosi continua, per cui gli stessi sentimenti del poeta si raffigurano come esseri tangibili, come gesti,come movimenti, come voci: insomma prendono attributi da personaggi, da dramatis personae. E perché, per esprimere quei personaggi, deve servirsi di mezzi prevalentemente lirici? Ciò dipende dal fatto che, quei personaggi, Saba li trova, li conosce, li accetta nei momenti in cui la loro cronaca, pure attaccata alle proprie determinazioni documentarie e di fatto, acquista una portata – per così dire – esemplare” (15). In particolare nel Canto a tre voci, la terza voce, il terzo personaggio è la poesia.
E qui la lettura di Debenedetti mette in scena due antitetiche modalità del fare poetico: “Nella misura in cui questo terzo personaggio può interpretarsi come una raffigurazione della poesia, bisogna dire che in quegli anni tutti parlavano di poesia pura: e Saba può anche aver desiderato di mettersi alla pari con questa poesia pura, ma subito era tratto a scambiarla molto paganamente, concretamente con una sorta di idolo che autoincensa la propria bellezza formale”.
E dopo aver letto l’autopresentazione del personaggio:
Io non so più dolce cosa
di pensarmi. Il puro amore
di cui ardo, dal mio cuore
nasce, e tutto a lui ritorna.
Debenedetti chiama in causa la psicoanalisi: “Se, consciamente o inconsciamente, Saba ha qui raffigurato anche la poesia pura, bisogna ammettere che, anche senza volerlo, egli se ne faceva un’idea disperata: qualcosa che nasce dall’ispirazione per tornare a se stessa come conseguimento, come forma raggiunta”.
E’ quanto mettono in scena i versi successivi:
Quando annotta e quando aggiorna
io mi beo d’esser me stessa.
E’ la cura mia indefessa
adornarmi per me sola.
La mia voce in alto vola,
scende al basso; il male e il bene
tutto è puro quando viene
all’azzurra mia pupilla,
come a un’acqua che tranquilla,
coi colori della sera
specchia i monti, la riviera,
i viventi, ogni lor cosa.
Recita il commento di Debenedetti: “In ingenui termini filosofici, si direbbe che è l’Io puro, il quale non ha altro oggetto che il puro Io. Ci si domanda quanto Saba sapesse di quella verginità assoluta, narcisistica, dello Spirito, per cui la parola stessa, il contatto con le cose, era già contaminazione e peccato: che ne sapesse dell’idea della poesia pura, che Valéry aveva sviluppato dalle premesse di Mallarmé, poesia anteriore alla parola, per la quale l’esprimersi, la parola necessaria a esprimersi, rappresentavano il fallimento del suo puro essere, il decadere nel transitorio, nell’accidentale, nel corruttibile. Certo, se sapeva di queste cose e di queste idee, in fondo non poteva condividerle, anche se per un attimo gli veniva la tentazione di rivaleggiare con loro in purezza. Il suo femminile Narciso, assente perché di se solo occupato, non resiste all’assenza assoluta: ascolta gli altri, li vede, discute con loro anche se per natura non si mescola alla baruffa dei loro torti e ragioni”.
E in una sorta di doppia drammatizzazione, quella del critico e quella del poeta in esame, la lettura enfatizza la inevitabilità per Saba di confrontarsi con la poesia ermetica: “Se personaggio ermetico è personaggio estraneo, qui Saba raggiunge, nella massima misura che gli è concessa, il personaggio ermetico. E lo raggiunge proprio in questa figurazione, nella quale ci pare di vedere l’immagine stessa della poesia. Ma ci dimostra appunto come per lui l’ermetismo sia impossibile: perché quell’estranea non riesce a serbare la sua estraneità; definisce e dichiara i suoi rapporti con noi, difficili quanto si vuole, disperati in quella alternativa e simultaneità di presenza e di assenza, ma non inspiegabili, anzi umanizzati, divenuti psicologicamente plausibili. La stessa disumanità dichiarata del personaggio è un suo modo di essere umano, si chiarisce e definisce tutta in termini umani. L’identificabilità, la riconoscibilità del personaggio distrugge l’ermetismo, in quanto lo incarna, gli conferisce connotati, tratti, movenze coi quali è possibile un dialogo, un confronto diretto sul terreno della vita quotidiana, dei sentimenti accessibili alla nostra esperienza più comune”.
Si direbbe che nel portare all’evidenza il momento di tentata convergenza e al contempo di fallimento di un qualsiasi contatto di Saba con la linea dei fautori della poesia ‘pura’, Debenedetti abbia indirettamente richiamato le vie e i modi attraverso cui l’’ermetico’ Luzi è stato ‘costretto’ ad aprirsi alla ‘calda vita’, la sua condivisione dell’idea sabiana che il pensiero può ‘farsi più puro’ proprio dove ‘più turpe è la via’.
Di un Saba sovvenevole ‘guida’ di Luzi nei primissimi anni Cinquanta è fuor di dubbio testimonianza autorevole Parca-villaggio, la poesia datata 1951 che, posta a introdurre la raccolta degli esordi nella edizione ne varietur, svolge la funzione di portale d’ingresso dell’ intero percorso poetico:
A lungo si parlò di te attorno ai fuochi
Dopo le devozioni della sera
In queste case grige ove impassibile
Il tempo porta e scaccia volti d’uomini.
Dopo il discorso cadde su altri ed i suoi averi,
furono matrimoni, morti, nascite,
il mesto rituale della vita.
Qualcuno, forestiero, passò di qui e scomparve.
Io vecchia donna in questa vecchia casa,
cucio il passato col presente, intesso
la tua infanzia con quella di tuo figlio
che traversa la piazza con le rondini (16).
Il personaggio drammatico della ‘vecchia donna’ che cuce il passato con il presente richiama immediatamente l’ explicit della sabiana Tre vie, nella raccolta Trieste e una donna:
le lavoranti scontano la pena
della vita: innocenti prigioniere
cuciono tetre le allegre bandiere (17)
E’ peraltro leggibile qui la conferma che non è il Saba più puro di Parole, i versi apparsi nella terza parte del Canzoniere della edizione Einaudi del 1945, a riscuotere il convinto consenso di Luzi nel difficile passaggio in cui il suo discorso poetico si apre al vissuto quotidiano, quanto piuttosto l’autore degli antichi versi di Trieste e una donna, del Canzoniere del 1921, o dei versi di Preludio e canzonette del 1927/28, nei quali si affaccia quella forma del dialogo scenico che, sia pure con modalità sue proprie, egli stesso praticherà intensamente negli anni Sessanta/Settanta con un momento apicale in quella sorta di saison en enfer che corrisponde a Nel magma, la raccolta poetica del 1963.
1) G. Debenedetti, Poesia italiana del Novecento, Milano, Garzanti, III° ed. 2000, p.107. E’ del 1950 il saggio di Luzi su Igitur di Mallarmé nel primo fascicolo (6 giugno) della rivista “paragone” di Roberto Longhi. Cfr. M. Luzi, Studio su Mallarmé, Firenze, Sansoni, 1952 e in particolare il saggio del 1959, La strada del simbolismo, che introduce l’antologia L’idea simbolista, Milano, Garzanti, 1959. Subito dopo aver richiamato la nota dichiarazione di Paul Valéry: “Le vent se lève. Il faut tenter de vivre”, Luzi avvia uno scoperto gioco di specchi: “E’ il grido nel quale si conclude la storia dell’idea simbolista; è anche la risposta che scriveremmo qui, quando ci fosse la certezza che il verso di Valéry sia da interpretarsi integrato in tutti i sensi: vivere nella vita, parlare nella lingua sicché la sintesi alla quale l’arte non può rinunziare senza perire avvenga nella vita; e la sua chiave sia posta nell’umano, qualunque reame debba aprire o rivelare” .
2) M. Luzi, Onore del vero, Venezia, Neri Pozza, ora in L’opera poetica, a c. di S. Verdino, I Meridiani, Milano, Mondadori, 1998, p.237. Nel 1957, con Onore del vero, Luzi vince il premio Marzotto per la poesia ex aequo con Saba.
3) G. Debenedetti, Luzi in Poesia italiana del Novecento, op. cit. pp:116-117. E’ assai probabile che il premio Marzotto per la poesia ricevuto nel 1957 ex aequo con Umberto Saba sia in parte dovuto all’interessamento di Debenedetti al quale Luzi deve anche la pubblicazione dal Saggiatore di Lo stile di Constant nel novembre 1962. Nella sezione Cronologia, in L’opera poetica a cura di S. Verdino, è riportato il passaggio di una lettera di Luzi a Debenedetti dell’aprile di quello stesso anno che è opportuno ripercorrere proprio in quanto autorizza a spingere molto all’indietro l’inizio della frequentazione da parte del poeta della produzione saggistica del critico torinese: “Caro Giacomino, con che gusto – altro che seduzioni intellettuali – si leggono i tuoi saggi! L’uomo che tu sei con la sua esperienza, con tutti i suoi appetiti vitali perfettamente dominati e per nulla mortificati, trasformati anzi in intelligenza e in moralità, fa ressa in quelle pagine e le dilata oltre il suo oggetto e pretesto. E’ quello che anche io avrei voluto ottenere: una realizzazione compiuta, un’espressione integrale di me attraverso il discorso critico come si conviene a uno scrittore che si serve di codesto mezzo e ha scelto quella forma. Avevo del resto tenuto presente il tuo esempio, anche se sono stato trascinato per altre vie , molto meno ‘maestre’ “.
4) Ivi, p.123.
5) Ivi, p.122.
6) Ivi, p.123.
7) G. Debenedetti, Il sorgere della poesia impegnata in Poesia italiana del Novecento, op. cit. p.220.
8) M. Luzi, Il giusto della vita in Tutte le poesie, Milano, Garzanti, 1979 ora in L’opera poetica, op. cit.
9) AA.VV., Saba, Trieste e la cultura mitteleuropea, a c. di R. Tordi, Milano, Fondazione Mondadori, 1986.
10) G. Raboni, Luzi, frammenti di un discorso poetico, “Corriere della sera”, 8 luglio 1990 e Nelle poesie di Luzi la Commedia del ‘900, “Corriere della sera”, 24 novembre 1998, ora in La poesia che si fa, a c. di A. Cortellessa, Milano, Garzanti, 2005, pp. 104-122.
11) M. Luzi, Il mio Saba in Saba, Trieste e la cultura mitteleuropea, op. cit. pp.73-74.
12) M. Luzi, Uccelli, Onore del vero in L’opera poetica, op. cit. p.209.
13) U. Saba, Storia e cronistoria del Canzoniere, Milano, Mondadori, 1948.
14) M. Luzi– M. Specchio, Luzi. Leggere e scrivere, Firenze, Nardi, 1993, p.80.
15) G. Debenedetti, Saba in Poesia italiana del Novecento, op. cit. pp. 127-173.
16) M. Luzi, Parca-villaggio in L’opera poetica, op. cit. p.9.
17) U. Saba, Tre vie, Trieste e una donna in Il Canzoniere, Torino, Einaudi, IV° ed. 1984, p.89.
[i] G. Debenedetti, Poesia italiana del Novecento, Milano, Garzanti, 3° ed. 2000, p.107. E’ del 1950 il saggio di Luzi su Igitur di Mallarmé, pubblicato nel primo fascicolo (6 giugno) della rivista “Paragone” di Roberto Longhi. Cfr. M. Luzi, Studio su Mallarmé, Firenze, Sansoni, 1952. Nel 1976 esce da Garzanti la ristampa aggiornata di L’idea simbolista (la prima edizione è del 1959);
[ii] M. Luzi, Onore del vero, Venezia, Neri Pozza, 1957, ora in L’opera poetica, a cura di Stefano Verdino, I Meridiani, Milano, Mondadori, 1998, p.237. Nel 1957, con Onore del vero, Luzi vince il premio Marzotto per la poesia ex aequo con Saba;
[iii] G. Debenedetti, Luzi, Poesia italiana del Novecento, op. cit., pp.116-117;
[iv] Ibidem p.123;
[v] Ibidem p.122;
[vi] Ibidem p.123;